Giovanni Paolo II, parlando ad un gruppo di intellettuali cattolici disse: “Se è vero che la fede non si identifica con nessuna cultura ed è indipendente rispetto a tutte le culture, non è meno vero che, proprio per questo, la fede è chiamata a ispirare, a impregnare ogni cultura …]. Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta”.
Dio e l’uomo sono realtà distanti. L’uomo non può conoscere Dio infinito ed eterno nel suo profondo mistero perchè “abita una luce inaccessibile, e nessuno tra gli uomini lo ha mai visto nè lo può vedere” (I Tm 6, 16). L’uomo è lontano per la distanza che la creazione pone tra Dio creatore e l’uomo-creatura, ma soprattutto è lontano per il fatto di essere peccatore (peccato originale e peccati personali). Dio ama l’uomo e vuole rivelarsi a lui per salvarlo. La missione di Gesù di Nazareth è appunto quella di unire Dio all’uomo e l’uomo a Dio. “Egli è il solo mediatore […) che ha dato se stesso in riscatto per tutti” (I Tm 2, 5-6).
Dio cioè non si rivela all’uomo se non per mezzo di Gesù, come faceva per mezzo dei profeti dell’Antico Testamento. Gesù non solo dice parole di Dio ma è Dio stesso che parla, è lui stesso la salvezza. Perciò l’uomo non incontra Dio al di là o al di fuori di Gesù, ma unicamente in Gesù. E’ questo il carattere specifico del cristianesimo, per cui esso si distingue da tutte le altre religioni, le quali hanno mediatori che non si identificano con la mediazione che essi esercitano. Ma se gli uomini incontrano Dio in Cristo in quanto egli è vero Dio, Dio incontra gli uomini nel Cristo in quanto è vero uomo e nella sua umanità porta tutto l’uomo e tutti gli uomini. Perciò Dio li salva dal peccato nella morte e nella risurrezione di Cristo e li rende suoi figli in lui.
Ma ci sono anche altre mediazioni “ministeriali” compiute dalla Chiesa in quanto essa non è altro che la presenza storica del dono che Dio fa di sè alle creature in Cristo, Perciò come Cristo è mediatore tra Dio e gli uomini, così – in totale dipendenza da lui – la Chiesa è mediatrice della salvezza. […] Vangelo e la storia sono realtà diverse ma fatte le une per le altre, per incontrarsi. Il Vangelo è per l’uomo nel senso che è un annuncio di salvezza per lui, e l’uomo è per il Vangelo in quanto ha bisogno della sua luce per conoscere il proprio mistero, e della sua forza per liberarsi dall’errore e dal peccato. Ma la mediazione culturale deve evitare due pericoli: quello di relativizzare il mistero di Dio, e quello di divinizzare l’uomo. Una mediazione riduzionista (o riduttiva) è un tradimento della verità cristiana. Bisogna invece avere il coraggio di presentare il cristianesimo integralmente, senza nascondere la “stoltezza” e lo “scandalo” della croce.
“Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani” (I Cor 1, 23).
L’opera di mediazione culturale è un dato costante del pensiero cristiano nei suoi venti secoli di storia, e si nota che sempre ha fatto ricorso ad una filosofia, convinti che la ragione umana fosse il mezzo più adeguato per attuare il dialogo fra Dio e l’uomo, tra il Vangelo e la storia. Così gli antichi Padri ricorsero al platonismo, al neoplatonismo e allo stoicismo, come i teologi medioevali si appellarono alla scolastica nelle sue grandi espressioni platonico-agostiniana e aristotelico-tomista.
Oggi si pongono problemi assai delicati per la mediazione culturale cristiana che deve affrontare un pluralismo con basi di immanenza e di soggettivismo e, in molti casi, con ermetica chiusura alla trascendenza. Mentre nel passato il problema era quello di salvaguardare l’identità dell’uomo e della storia, oggi si tratta di difendere l’identità del messaggio cristiano.
C’è infatti il rischio che, nel tentativo di permeare in maniera efficace la mentalità dell’uomo di oggi, il cristianesimo diventi una cultura e una ideologia. Una tra le tante. L’espressione più radicale della “diversità” di Dio e del Vangelo è il barthismo, per il quale Dio è “totalmente Altro” e il Vangelo si pone in opposizione all’uomo, peccatore in radice, e alla storia, che è storia di peccato. Quanto alla storia non ci sarebbero – secondo Barth – segni di un’attesa di Dio.
La grazia salvatrice di Dio viene dall’alto (“sola fides – sola gratia”), senza che la ragione abbia nulla da dire o da fare.
Ma – sia chiaro – ciò non è conforme alla visione che la Chiesa e la tradizione cattolica hanno di Dio e dell’uomo. Per la Chiesa infatti la ragione umana può conoscere Dio con certezza e l’uomo non è stato radicalmente e totalmente corrotto dal peccato, come riteneva Lutero.
L’epoca del secolarismo non ha confronti con nessun’altra epoca, perche l’uomo ha sempre aspirato a qualcosa di più e di diverso, non accettando di restare chiuso nella propria finitezza. A questo punto, un discorso su Dio ha ancora senso oppure la rottura è tanto radicale che ogni tentativo è destinato all’insuccesso?
Guardando la realtà sino in fondo, spassionatamente, ci accorgiamo che anche l’uomo della città secolare, almeno in certi momenti, si pone i grandi interrogativi sul senso della vita, sulla sofferenza, sulla morte, sul destino dell’uomo e della storia, tanto più che egli constata con i propri occhi l’enorme fragilità di quanto costruisce, il fallimento dei suoi progetti più ambiti.
D’altra parte, proprio nell’uomo della città secolare nascono desideri ed esigenze di solidarietà, di comunione e di giustizia, in cui il Vangelo non può essere assente. Nascono aspirazioni religiose che si cerca di soddisfare col ricorso – piuttosto frequente – alle religioni orientali o all’astrologia e allo spiritismo. Dunque non è spento nel cuore dell’uomo il bisogno dell’Assoluto.
“Chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui più uomo” (Gaudium et Spes, n. 41).
E’ un augurio, che nasce dalla speranza e che può diventare certezza.
Cipriano Ricotti OP, “Domenicani”, anno XV – 1981
Foto di Masashi Wakui da Pixabay
Scopri di più da Club Theologicum
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
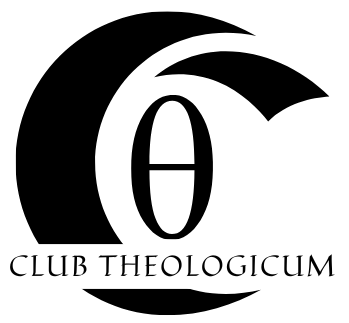

Lascia un commento