Nato a Montepulciano, in Toscana, il 4 ottobre 1542 e morto a Roma il 17 settembre 1621, Roberto Bellarmino è venerato come santo dai cattolici, che lo annoverano tra i Dottori della Chiesa.
I suoi genitori erano Vincenzo Bellarmino e Cinzia Cervini, sorella di Papa Marcello II (morto nel 1555). Nel 1560, Bellarmino entrò nel Collegio Romano dei Gesuiti, dove emise i primi voti e iniziò a studiare la filosofia aristotelica. Dopo un breve periodo di studi di teologia tomistica a Padova, nel 1569 fu inviato a Lovanio, in Belgio, diventando il primo professore gesuita della locale università e venne ordinato sacerdote nel 1570.
A Lovanio, Bellarmino insegnò teologia basandosi sulla Summa Theologiae di san Tommaso d’Aquino e iniziò a lavorare alla sua opera principale, le Disputationes. L’università di Lovanio era un baluardo della Chiesa cattolica contro i riformatori, ma il suo insegnamento era caratterizzato da un’erudizione pratica e difensiva piuttosto che speculativa. La storia della Chiesa cattolica e gli studi patristici erano infatti assai poco praticati. Per porre rimedio ad una tale situazione, Bellarmino dedicò le sue energie allo studio delle Scritture, della storia ecclesiastica e della patristica per sistematizzare la dottrina della Chiesa contro gli attacchi dei riformatori. Durante questo periodo, il futuro cardinale scrisse una grammatica ebraica e compilò il De Scriptoribus ecclesiasticis, un’opera dedicata alla patristica.
Nel 1576, Gregorio XIII incaricò Bellarmino dell’insegnamento della teologia agli studenti missionari inglesi e tedeschi del Collegio Romano, incarico che mantenne fino al 1588. Durante tale periodo, questi produsse un’ampia sintesi della teologia protestante e cattolica, pubblicata in tre volumi e intitolata Disputationes de Controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis haereticos (Igolstadt, 1586-88-93). Questa opera monumentale è considerata la più importante di quelle da lui prodotte e contiene molte delle idee che questi svilupperà in seguito, con sezioni notevoli sul potere temporale del papa e sul ruolo dei laici.
Le Disputationes organizzano in modo sistematico la caotica polemica tra riformatori e cattolici, e la critica di Bellarmino alla teologia riformata è piuttosto bilanciata, evidenziando anche i punti di forza di quest’ultima, ove necessario. Questo approccio contrasta con la maggior parte degli scritti polemici dell’epoca. L’opera era sufficientemente compatta e maneggevole da poter essere sempre tenuta a portata di mano, ma offriva al contempo una difesa a tutto tondo della teologica cattolica rispetto alle critiche dei protestanti. Era talmente efficace nelle sue argomentazioni ed ebbe una diffusione talmente ampia che i protestanti istituirono addirittura delle cattedre specifiche che avevano lo scopo di insegnare a controbattere alle sue tesi.
Nel 1584, Bellarmino pubblicò De translatione Imperii Romani, un altro scritto molto importante che si concentrava sul tema del potere papale. Nel 1588, divenne direttore spirituale del Collegio Romano, dove le sue lezioni di catechesi portarono alla creazione di due catechismi scritti in italiano: la Dottrina cristiana breve per i bambini (Roma, 1597) e la Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana per gli insegnanti (Roma, 1598). Entrambi i manuali, approvati solennemente da Clemente VIII, furono ampiamente tradotti e utilizzati fino alle soglie del XX secolo. In particolare il secondo dei due, per la sua impostazione dialogica, ebbe una fortuna davvero incredibile, tanto da godere di una diffusione e di un apprezzamento persino superiore a quelli del Catechismo Romano.
Nel 1590, Bellarmino si trovò ad affrontare una seria difficoltà riguardo alla sua teoria del potere papale indiretto. È stato ipotizzato che solo la morte improvvisa di Papa Sisto V abbia impedito al primo volume delle Disputationes, in cui era esposta questa teoria, di essere inserito nell’Indice dei libri proibiti.
Il Nostro fu rettore del Collegio Romano (1592), provinciale della provincia napoletana dei gesuiti (1594) e teologo di Clemente VIII (1597), che lo nominò cardinale nel 1599. Da quel momento, questi fu membro di tutte le Congregazioni romane e di numerose commissioni. Una delle sue preoccupazioni costanti fu la disciplina dei vescovi, come la loro nomina, residenza e trasferimento.
Nel corso della sua carriera, Bellarmino fu coinvolto in vari processi ecclesiastici, tra cui quello a Giordano Bruno. Il processo a Bruno iniziò nel 1593 e durò sette anni, fino al 1600. Durante lo stesso, il Nostro cercò a più riprese di convincere Bruno ad abiurare le sue tesi. Si dice che, quando infine si rese conto che quest’ultimo non aveva alcuna intenzione di ritrattare, Bellarmino si mise a piangere, consapevole che ciò avrebbe portato alla condanna a morte dello stesso, che fu infine eseguita il 17 febbraio 1600.
All’inizio del secolo, Bellarmino partecipò anche alla controversia sulla grazia efficace. Difese il suo discepolo Leonardo Lessio, scrisse una relazione, De Controversia Lovaniensi, per il presidente della Congregatio de Auxiliis, e discusse su carta con Domingo Báñez. Nel 1602, Clemente VIII lo consacrò personalmente arcivescovo e lo inviò a Capua, dove visse una vita pastorale dedicata alla carità, alla predicazione e alla riforma. Nel 1605, però, Paolo V lo richiamò a Roma per servire più efficacemente la Chiesa universale.
Negli anni successivi, Bellarmino fu coinvolto in diverse controversie riguardanti il potere papale. Tra il 1606 e il 1607, si scontrò con la Repubblica di Venezia sulle immunità clericali. Dal 1607 al 1609, affrontò il re d’Inghilterra Giacomo I sul diritto divino dei re e sul giuramento di fedeltà inglese. Nel 1610, combatté contro il gallicanesimo di William Barclay e Roger Widdrington, scrivendo il famoso Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus adversus Gulielmum Barclaeum. Bellarmino non fu l’inventore della teoria del potere indiretto del papa negli affari temporali, ma riuscì a darne una formulazione tale da poter essere applicata efficacemente nelle relazioni tra Chiesa e Stato. Distinse chiaramente tra il potere temporale e quello spirituale del papa, enfatizzando il primato del potere spirituale della Chiesa. Sosteneva che, poiché il potere spirituale è primario e quello temporale secondario, il papa può intervenire in questioni temporali che influenzano quelle spirituali. Tuttavia, le sue applicazioni pratiche di questi principi spesso mescolavano aspetti permanenti e contingenti dell’uso del potere della Chiesa. Bellarmino considerava lo Stato come parte di un’unica società con la Chiesa, piuttosto che come entità indipendente. Inoltre, non sempre distingueva chiaramente tra i due motivi per cui la Chiesa interveniva negli affari temporali: il diritto divino o il fallimento della società politica. C’è da dire, comunque, che la sua comprensione della storia fu certamente influenzata dalla qualità delle fonti disponibili a suo tempo.
L’ultima grande controversia nella vita di Bellarmino avvenne nel 1616, quando fu incaricato di ammonire Galileo, che ammirava molto. L’ammonizione fu fatta a nome del Sant’Uffizio, che aveva dichiarato la teoria eliocentrica di Niccolò Copernico contraria alle Scritture. Bellarmino, pur partecipando alle commissioni per la revisione della Vulgata e del Nuovo Testamento greco, sembrava meno esperto di Galileo nell’interpretazione delle Scritture secondo gli insegnamenti del Concilio di Trento. Egli esitò anche su come conciliare le Scritture con la scienza. Durante il confronto con Galileo, Bellarmino suggerì allo scienziato di presentare la sua teoria eliocentrica come una mera ipotesi matematica. Questo consiglio mirava a evitare la censura, permettendo a Galileo di continuare le sue ricerche senza entrare in conflitto diretto con la Chiesa. Bellarmino cercava così di trovare un equilibrio tra la fede e la scienza, mantenendo il rispetto per entrambe le discipline.
Verso la fine della sua vita, il Nostro pubblicò diverse opere ascetiche, tra cui In omnes Psalmos dilucida exposito (Roma, 1611), De gemitu columbae (Roma, 1615) e De arte bene moriendi (Roma, 1620). Questi scritti riflettono la sua profonda spiritualità e la sua dedizione alla vita religiosa. Egli, infatti, per tutta la vita praticò l’abnegazione, la povertà, il disinteresse e la devozione al dovere, e promosse una speciale venerazione per san Francesco d’Assisi.
Il suo processo di canonizzazione iniziò già nel 1627, ma fu ritardato per motivi politici fino al 1930. Nel 1931, Papa Pio XI lo dichiarò Dottore della Chiesa, riconoscendo così il suo contributo significativo alla teologia e alla spiritualità cattolica.
Il corpo di Bellarmino riposa nella Chiesa di Sant’Ignazio a Roma e la sua memoria cade il 17 settembre.
Adriano Virgili
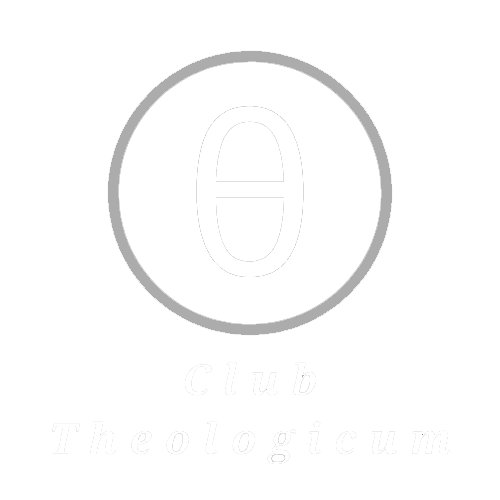

Lascia un commento