Introduzione.
Ponzio Pilato ha un ruolo particolare nella fede dei cristiani, tanto da essere citato persino nel Credo. I Vangeli ci danno di lui un ritratto scarno e a tratti contraddittorio. Ma chi fu veramente costui? Cosa ci dice la storia? Cercherò di riassumerlo nelle righe che seguono.
- Presentazione.
Pilato fu prefetto romano della Giudea dal 26 al 37 d.C. Non si sa praticamente nulla della sua vita prima dell’arrivo in Giudea. Apparteneva alla classe equestre (il gradino più basso della nobiltà romana); godeva di una nascita libera e di un certo livello di ricchezza; e può essersi distinto sul campo di battaglia prima della sua nomina (che secondo alcuni storici potrebbe risalire al 10 d.C. anziché al 26, come viene generalmente accettato dai più). Si dice spesso che Pilato dovesse la sua posizione all’influenza di Seiano, il presunto prefetto della Guardia Pretoriana, uomo con una notevole influenza sull’imperatore Tiberio e che nutriva un forte sentimento antisemita. Le prove dell’antisemitismo di Seiano sono tuttavia non conclusive e si devono per lo più alla testimonianza di Filone di Alessandria, i cui scritti, però, sono notoriamente caratterizzati da un buon tasso di retorica; Seiano può essere stato il protettore di Pilato, ma il suggerimento che egli (e quindi Pilato) fosse antisemita sembra poco credibile. Data l’espulsione degli ebrei da Roma da parte di Tiberio nel 19 d.C. (Svetonio, Tib. 36.1; Tacito, Ann. 2.85.5), tuttavia, è possibile che l’azione di Pilato in Giudea sia stata improntata secondo un atteggiamento meno accondiscendente nei confronti della popolazione locale rispetto a quello dei suoi predecessori.
Il titolo di Pilato, prefetto o eparchos in greco, denota un incarico di tipo militare. Nel 26 d.C., la Giudea era sotto il diretto dominio romano da soli venti anni. Il primo dovere del prefetto era quello di mantenere l’ordine nella piccola ma spesso problematica provincia. In questo aveva a disposizione solo truppe ausiliarie, pari a cinque coorti di fanteria e un reggimento di cavalleria; in tempi di emergenza poteva però rivolgersi al vicino legato di Siria, che invece aveva a sua disposizione ben quattro legioni romane. Come i precedenti prefetti, Pilato stabilì il suo quartier generale e il suo capoluogo di provincia nella città costiera (e prevalentemente gentilizia) di Cesarea Marittima. La maggior parte delle truppe a sua disposizione erano di stanza qui, anche se altre erano sparse in tutta la provincia, con una piccola guarnigione permanente ospitata nella fortezza Antonia a Gerusalemme, proprio di fianco al Tempio. A volte, in particolare durante le feste, quando l’afflusso di decine di migliaia di pellegrini nella città e il generale clima di entusiasmo nazionalistico potevano causare considerevoli problemi di ordine pubblico, il governatore visitava Gerusalemme accompagnato da truppe aggiuntive.
Tra gli altri compiti di Pilato c’erano la responsabilità di amministrare la giustizia nella provincia e la supervisione della riscossione delle imposte. Come alcuni altri governatori romani, anche lui coniava monete di bronzo. Queste contenevano simboli del culto romano, ma non immagini umane; il loro uso fino all’epoca di Agrippa I (41-4 d.C.) suggerisce che non erano probabilmente considerate offensive dagli ebrei residenti nella provincia. I precedenti prefetti avevano nominato anche i sommi sacerdoti. Quando Pilato giunse in Giudea, era in carica il sommo sacerdote Caifa, che era stato nominato dal suo predecessore, Grato, e che vi rimase durante tutta la permanenza del legato nella provincia. È quindi lecito ipotizzare che i due uomini lavorassero bene insieme, o forse (come è stato da alcuni suggerito) che il potere di nominare i sommi sacerdoti fosse stato trasferito da Germanico al governatore della Siria.
- Fonti Extra bibliche.
A parte un breve riferimento a Pilato legato all’esecuzione di Gesù in Tacito (Ann. 15.44), quasi tutte le nostre informazioni su costui provengono da due scrittori ebrei, Filone di Alessandria e Flavio Giuseppe, oltre che dai Vangeli, ovviamente.
Filone

Filone, contemporaneo di Pilato, fornisce un resoconto dettagliato di un episodio in cui questi pose degli scudi dorati all’interno del palazzo di Erode (la sua residenza quando si trovava a Gerusalemme) in onore dell’imperatore. Tali scudi recavano iscrizioni con il nome del dedicante (presumibilmente Pilato) e del dedicatario (Tiberio). Tale fatto causò notevole risentimento tra gli ebrei, li consideravano offensivi. L’offesa era dovuta con tutta probabilità al nome completo di Tiberio (Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus) che comprendeva un riferimento al padre adottivo di costui, il “deificato Augusto”. Il popolo si appellò senza successo a Pilato stesso, per poi ricorrere direttamente all’imperatore Tiberio, il quale fu molto contrariato dalla cosa e ordinò l’immediata rimozione degli scudi in oggetto (A Gaio 299-305).
In questo racconto vengono dette diverse cose spiacevoli in merito al prefetto romano: Filone suggerisce che l’intenzione di Pilato nel predisporre gli scudi era di infastidire gli ebrei (299), dice che era “un uomo dal carattere inflessibile, testardo e crudele” (301), e parla della “sua venalità, la sua violenza, i suoi furti, le sue aggressioni, il suo comportamento offensivo, le sue frequenti esecuzioni di prigionieri di cui non era stata provata la colpevolezza e la sua infinita e selvaggia ferocia” (302). La narrazione di Filone, tuttavia, non può essere presa per buona. Fa parte di una lettera scritta a Caligola per cercare di dissuadere l’imperatore dall’erigere una sua statua nel Tempio di Gerusalemme. L’intento di Filone è quello di mostrare come una piccola violazione della legge abbia fatto arrabbiare Tiberio. La retorica dell’opera tenta di mettere il più possibile in cattiva luce il carattere di Pilato al fine di sottolineare le buone qualità di Tiberio. C’è comunque da notare che sarebbe stato difficile per Filone scrivere un tale resoconto se Pilato fosse stato generalmente noto come una persona giusta e morigerata.
In questo caso specifico, non sembra che l’offesa compiuta dal governatore fosse così pesante. Il quartier generale romano era chiaramente il luogo più appropriato per porre gli scudi e Filone stesso ammette che erano all’interno dello stesso e non contenevano immagini; presumibilmente c’erano molti altri oggetti in quel luogo contenenti il nome ufficiale dell’imperatore. La riluttanza di Pilato a rimuovere gli scudi non era probabilmente dovuta al timore che un’ambasciata potesse esporre i suoi crimini, ma alla paura della reazione di Tiberio se fosse venuto a conoscenza del fatto che aveva fatto deporre un allestimento realizzato in suo onore.
Giuseppe Flavio

Giuseppe Flavio, scrivendo alcuni decenni dopo, aggiunge altri tre incidenti (oltre al controverso brano in cui narra dell’esecuzione di Gesù, Ant. 18.63-64). Il primo, narrato sia in B.J. 2.169-74 che in Ant. 18.55-59 (con lievi variazioni), sembra essersi verificato all’inizio del governatorato di Pilato, forse durante il suo primo inverno. Lo storico ebreo dice che costui, col favore delle tenebre, spostò a Gerusalemme un distaccamento di truppe i cui vessilli contenevano immagini dell’imperatore. Il giorno dopo, quando i gerosolimitani videro tali immagini, si recarono a Cesarea e fecero appello in massa per la loro rimozione. Poiché i vessilli di una unità militare erano inseparabili dalla stessa, la richiesta equivaleva a una richiesta di allontanamento dello squadrone da Gerusalemme. Il sesto giorno Pilato convocò il popolo, minacciando una strage se questo avesse continuato la protesta. Il suddetto, tuttavia, non retrocesse e molti tra le sue fila si dichiararono pronti a morire piuttosto che trasgredire la tradizione. Pilato, intimorito da tanta devozione religiosa, rimosse il distaccamento di truppe.
Anche in questo caso, il resoconto dell’incidente deve essere attentamente vagliato. Flavio Giuseppe è ansioso di sottolineare la forza della devozione ebraica e, al contempo, di accusare Pilato di aver deliberatamente voluto sovvertire le pratiche giudaiche al fine di suggerire come una delle cause della rivolta ebraica del 66 d.C. fosse il deteriorarsi progressivo della qualità dell’amministrazione romana della Giudea. L’incidente mostra probabilmente l’intenzione di un nuovo prefetto di inaugurare il suo governatorato con mano ferma, ma il fatto che alla fine si sia tirato indietro suggerisce che questi avesse in antipatia l’idea di ricorrere agli spargimenti di sangue e la volontà di dimostrarsi accondiscendente verso gli ebrei al fine di mantenere la pace nella provincia.
Il secondo evento narrato da Giuseppe, sempre in B.J. 2.175-77 e in Ant. 18.60-62, riguarda la costruzione di un acquedotto per Gerusalemme con il denaro del tesoro del Tempio. Si trattava presumibilmente di un’impresa lodevole, che avrebbe portato enormi benefici alla città (e al Tempio). La Mishnah permette l’uso del denaro del Tempio per “i bisogni della città” (m. Shek 4.2) e Pilato aveva presumibilmente il permesso di Caifa e delle autorità del Tempio. Ciononostante, un giorno in cui egli era a Gerusalemme (forse per una festa), si verificò una rivolta popolare durante la quale molti furono uccisi dalle truppe romane o perirono travolti dalla folla in fuga. La causa precisa del tumulto è incerta: in B.J. si suggerisce che Pilato stava drenando il tesoro, forse chiedendo più di quanto necessario; in Ant., invece, si dice che il problema era legato all’opera stessa (18.60), probabilmente in relazione al percorso che doveva avere l’acquedotto o il metodo per la sua costruzione (che forse comprometteva la purezza dell’acqua). Non è comunque chiaro quale sia la data precisa di questo incidente.
Il terzo e ultimo caso narratoci dal Giuseppe Flavo si trova in Ant. (18.85-89), dove si racconta la sequenza degli eventi che portarono alla rimozione di Pilato quale governatore della Giudea. Un uomo che si spacciava per il Messia samaritano (il Taheb) convinse un gran numero di samaritani a scalare il monte Gerizim, ove diceva che avrebbe disseppellito alcuni vasi lì depositati da Mosè. I suoi seguaci presero le armi e si riunirono nel vicino villaggio di Tirathana, preparandosi a scalare la montagna. Prima che questi potessero partire, però, Pilato bloccò il loro percorso con un distaccamento di cavalleria e di fanteria; molti samaritani furono fatti prigionieri e i loro capi furono giustiziati. I samaritani si lamentarono della cosa con Vitellio, il legato della Siria, sottolineando come l’uso della forza da parte di Pilato fosse stato eccessivo in quella circostanza (18.88). Anche in questo caso, è importante vedere oltre il pregiudizio negativo di Giuseppe Flavio. Forse il prefetto usò una mano eccessivamente pesante in quella circostanza, ma va anche notato che qualsiasi governatore provinciale che non prendesse sul serio un fatto del genere sarebbe venuto meno ai suoi doveri. Vitellio ordinò a Pilato di recarsi a Roma per rispondere direttamente al cospetto dell’imperatore delle accuse che gli erano state mosse. Ciò non indica necessariamente che il legato ritenesse giustificate le accuse contro di lui: Vitellio era il superiore di Pilato in Oriente, ma solo l’imperatore poteva giudicare un governatore provinciale. Il prefetto della Giudea si affrettò a partire per Roma, ma al suo arrivo scoprì che Tiberio era morto (37 marzo), dettaglio che colloca la sua partenza dalla provincia all’inizio del 37 d.C.
- Fonti Bibliche.
A parte un breve riferimento in 1Tim 6,13, Pilato appare nel Nuovo Testamento solo nei Vangeli. Luca 13,1 allude ad alcuni galilei “il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici” e Marco 15,7 (seguito da Lc 23,19) menziona “il tumulto” durante il quale Barabba era stato arrestato. Entrambi gli incidenti sono stati a volte collegati con la rivolta associata all’acquedotto, ma senza alcuna certezza. Il lungo mandato di Pilato fu caratterizzato senza dubbio da molti incidenti sconosciuti; i piccoli disordini e gli agitatori erano probabilmente una caratteristica comune, soprattutto durante le feste. I rimanenti riferimenti a Pilato nei Vangeli concernono agli eventi che condussero alla morte di Gesù.
Tutti e quattro i vangeli concordano sul fatto che Gesù fu consegnato a Pilato dai capi ebrei, anche se solo Giovanni registra la presenza di soldati romani durante l’arresto di Gesù, un dettaglio che fa pensare a un precedente coinvolgimento dei romani stessi nella faccenda (Gv 18,3). Da questo punto in poi, però, i vangeli differiscono enormemente per quanto riguarda la sequenza precisa degli eventi, i dettagli dell’azione giudiziaria contro Gesù e l’atteggiamento di Pilato nei suoi confronti e di quello dei suoi avversari ebrei.
Si è soliti dire che l’immagine di Pilato che emerge dal Vangelo secondo Marco è quella di un uomo debole, che tenta invano di liberare Gesù, ma che alla fine è costretto a condannarlo alla crocifissione. Leggendo il tutto nel contesto del primo secolo, tuttavia, una tale interpretazione appare poco realistica: i ripetuti riferimenti del governatore a Gesù come “Re dei Giudei” o “il vostro Re” sembrano calcolati per mettere alla prova la folla, per vedere se questa sia disposta a schierarsi a favore di un leader messianico, piuttosto che riconducibili a seri tentativi di liberarlo. Non c’è dubbio che Marco attribuisca la responsabilità primaria della morte di Gesù ai capi degli ebrei, ma Pilato non rimane senza colpa. Giovanni presenta un Pilato duro e beffardo. La scena centrale della narrazione del processo rappresenta un Gesù flagellato e sbeffeggiato, uno sbeffeggiamento che continua fino alla drammatica scena finale, quando dopo che i capi giudei hanno dichiarato di non avere “nessun re all’infuori di Cesare” (Gv 19,15), Pilato condanna Gesù alla crocifissione.
Il racconto di Matteo, che segue da vicino Marco, si concentra nel tentativo di addossare tutta la colpa della condanna di Gesù sui capi dei giudei, ponendo quindi in secondo piano la responsabilità dell’autorità romana: così introduce la moglie di Pilato, che dichiara Gesù giusto; la lavanda delle mani del governatore romano (un rituale che segue il Dt 21,6-9) e la dichiarazione della propria innocenza; l’accettazione definitiva della volontà della folla (27,25).
Al contrario, il Pilato di Luca è un debole. Di fronte a tre accuse specifiche contro il prigioniero, egli rifiuta di prendere sul serio il caso e lo manda ad Antipa (che era anche lui a Gerusalemme per la festa). Tre volte Pilato dichiara Gesù innocente, ma non se la sente di liberarlo di fronte all’opposizione della folla dei giudei. Luca è ansioso di dimostrare che Gesù era innocente secondo la legge romana e che a determinare la sua condanna furono una combinazione della tradizione ebraica di uccidere i profeti (13,34; 24,19-20) e di un governatore romano inadeguato a ricoprire il proprio ruolo.
Considerate le differenze nei racconti dei Vangeli sul procedimento giudiziario romano contro Gesù e le loro finalità chiaramente teologiche, non sorprende che sovente siano stati espressi dubbi sul coinvolgimento di Pilato nella cosa. La crocifissione era chiaramente una punizione romana, ma l’approssimarsi della Pasqua, l’alto livello di allerta in città e il basso ceto sociale a cui apparteneva Gesù, si sostiene, non rendevano necessario salire molto in alto nella catena di comando romana perché questi fosse mandato a penzolare da una croce. Si è sostenuto che Gesù avrebbe potuto essere arrestato dopo l’incidente del Tempio e crocifisso quasi immediatamente, senza alcun coinvolgimento personale di Pilato.
Questo è naturalmente possibile, ma molto dipende da come interpretiamo i vangeli. Anche se c’è disaccordo sui dettagli, tutti e quattro concordano sul fatto che Gesù fu consegnato a Pilato all’alba, che il governatore ascoltò il prigioniero (per quanto brevemente) e che in seguito a questa udienza questi diede l’ordine di crocifiggerlo. Anche Giuseppe Flavio parla del coinvolgimento diretto di Pilato nella morte di Gesù, Ant. 18.64. La storia di Gesù figlio di Anania nel 62 d.C. mostra poi che non era insolito per un governatore romano interessarsi personalmente di singoli casi: quest’uomo (che profetizzava contro il Tempio) fu arrestato e processato dai capi ebrei, per poi essere consegnato al procuratore Albino, che decise che era pazzo, lo fece frustare e lo fece rilasciare (B.J. 6.300-9). Gesù di Nazareth era sicuramente considerato più pericoloso di Gesù figlio di Anania: aveva un seguito e aveva già causato un gran trambusto nel Tempio. Se Albino si occupò personalmente di un tipo come Gesù figlio di Anania, non è improbabile che Pilato abbia fatto lo stesso con Gesù di Nazareth, soprattutto in ragione del fatto che questi svolgeva il suo ministero pubblico ormai da diversi anni e con un certo seguito, per cui è se non altro probabile che il governatore romano ne avesse già sentito parlare in precedenza. Nel complesso, quindi, non c’è motivo di dubitare del coinvolgimento personale di Pilato nella condanna di Gesù alla crocifissione.
Adriano Virgili
Bibliografia.
Bond, H. K. Pontius Pilate in History and Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Crossan, J. D. Who Killed Jesus? Exposing the Roots of Anti-Semitism in the Gospel Story of the Death of Jesus, San Francisco, CA: Harper, 1996.
Schurer, E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, revised and ed. G. Vermes, F. Millar, and M. Goodman, Edinburgh: T. & T. Clark, 1973-87, Vol. 1.
Winter, P. On the Trial of Jesus, Berlin: Walter de Gruyter, 1961.
Schiavone, A. Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, Torino: Einaudi, 2016
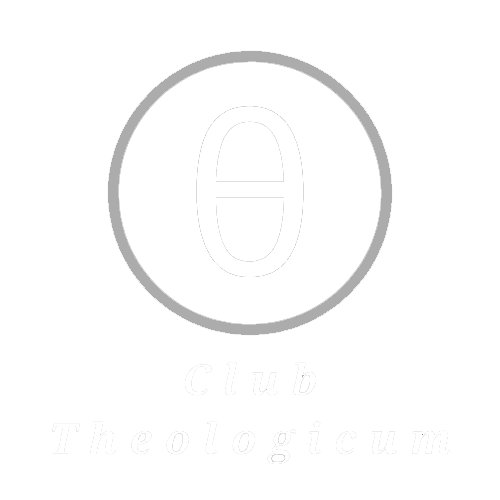

Ho apprezzato molto, a livello narrativo, il libro “Memorie di Ponzio Pilato” di Anne Bernet. Qualcuno qui sa se può essere considerato anche attendibile storicamente?
"Mi piace""Mi piace"
Dovrei chiedere all’autore, purtroppo non ho letto quel libro. grazie per la domanda
"Mi piace""Mi piace"
Non ho letto il volume in oggetto, quindi non ti so dire. Ciò che ho riportato nell’articolo e rappresentativo dello stato della questione in ambito scientifico attorno alla figura di Ponzio Pilato, per cui, se nel libro in oggetto si ricalcank grossomodo le cose che ho scritto qui, allora l’autrice del romanzo ha fatto bene i compiti.
"Mi piace""Mi piace"