Ripubblichiamo questa bellissima intervista con la cara amica e poetessa Francesca Serragnoli, ringraziando l’autrice e il blog https://paperstower.wordpress.com/

Francesca Serragnoli è nata a Bologna nel 1972, dove si è laureata in Lettere Moderne. Ha lavorato presso il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna fino al 2007. Suoi testi di poesia sono apparsi nelle antologie “I cercatori d’oro”, a cura di D. Rondoni (Forlì, La Nuova Agape, 2000); “Nuovissima poesia italiana”, a cura di M. Cucchi e A. Riccardi (Mondadori, 2004); “Mosse per la guerra dei talenti”, a cura di Marco Merlin (Fara Editore, 2007); “La stella polare”, a cura di D. Brullo (Città Nuova, 2008); “Jardines secretos, Joven Poesìa Italiana, a cura di E. Coco (Sial, Madrid, 2008); “Qui regna amor” antologia poesia italiana in cd (Argentina);”Mana scrie sunetul” a cura di E. Macadan (Eiekon, Romania 2014); in uscita “Esplendor en las sombras – Tres voces italianas contemporáneas, a cura di E. Tardonato Faliere e M. C. Micetich (Editorial Hdj, Argentina) e su varie riviste. Ha pubblicato la raccolta “Il fianco dove appoggiare un figlio (Bologna 2003, premio Camaiore Opera prima, nuova edizione Raffaelli Editore 2012) e Il rubino del martedì (Raffaelli Editore, 2010; Premio Alpi Apuane ex equo, Premio Mario Luzi selezione, Premio Laurentum II classificata, selezione Premio Ceppo Pistoia). Collabora con il Centro Studi Sara Valesio. Attualmente è perfezionanda presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.
Qual è il tuo approccio a spiritualità e realtà?
E’ una domanda che mi lascia, nell’immediato, un po’ perplessa a fissare il vuoto, a cercare qualcosa da dire. Intanto sento lo stridore della separazione fra i due piani, stridore che si sperimenta proprio quando si ritiene lo spirito una specie di evanescenza religiosa o laica e si pensa ad esso come qualcosa che ripara dal pondus del vivere, a una via di fuga dalla realtà. Ma che cos’è lo spirito? Anni fa chiesi al mio prof. di poter fare la tesi di laurea magistrale in Scienze religiose sul significato dello spirito proprio perché non capivo. Lascia stare disse. E io cretina immaginavo di poter afferrare lo spirito in un centinaio di pagine, capirne l’origine l’essenza e le istruzioni per l’uso. Tutto ciò che c’è di teorico sull’argomento è reperibile nelle biblioteche da fonti filosofiche, teologiche, new age, psicologiche e anche estetiche. Parlare dello spirito, non secondo istruzioni per l’uso, come si potrebbe? Secondo le mie fonti religiose dovrei soffiare come fa a volte il mio prof. nei suoi libri fuuuu. Boh.
In poesia, parlare di spirito non passa mai di moda, e riconduce a quella parola che sentiamo, in maniera errata, come antagonista della carne e che si chiama anima, anemos, vento, spirito. Ecco sicuramente c’è uno spirito santo (cit.) e uno spirito che anela ad essere in un certo senso autonomo, laico, non creato ma ritrovato e che è come una piccola divinità solo per artisti, ricavabile da un intuito canino.
Scollare lo spirito dalla realtà, anche questo mica facile. La rete, senza realtà, per questa farfalla, quindi la rete senza rete, non credo catturi nulla. Quindi? Inoltre che differenza potrebbe esserci fra la carne e lo spirito? Che garanzia abbiamo che lo spirito non muoia come la carne? Poi ci sarebbe il discorso sulla differenza fra bellezza estetica e bellezza spirituale. Ma perché sarebbe poi bello lo spirito? Solo perché è ciò che di noi e del mondo non muore o promette, a parola, di non farlo? Anche qui mi permetto di avere una opinione: a che serve l’eternità se lo scopo delle nostre vite fosse quello di girare la ruota del mondo come eterni criceti, senza sapere a che serve farlo? T’immagini Luca, vivere per 10 mila anni… anche la terra verrebbe a noia. Ci bastino dieci minuti di vita per domandarci il senso di quei 10 minuti. Quella è anche una sorta di eternità. Parlare dello spirito è materia pesante. Io credo che lo spirito soffi dove vuole e per fortuna. Credere a questo mi basta per non fare troppe congetture. Mi ci vorrebbe molta più fede a credere a chi dice che non esiste. Ma nella poesia, per fortuna, il problema non è discutibile in termini filosofici o teologici. Sono altri piani anche se s’intersecano in alcuni punti. Ma in fondo di questo verso, come direbbe Walcott, si sta aprendo una porta. E il gabbiano che si posa è un gabbiano o un simbolo? Tutti e due.
Io mi relaziono a malapena con la realtà. Quell’attrazione ventosa inafferrabile in sovrappiù e inutile, apparentemente selvatica, intuita dalla vista o dall’odorato, dal tatto o dal gusto, udita; quella mano dentro al costato che le cose ci infilano ci disorienta, ci toglie per un attimo dal peso del tempo, ci solleva qualche centimetro da terra. La poesia è una primizia di questo, il burattino in balia della fata turchina. La vera epifania è la carne infranta dalle onde della morte. Mi si capovolge il pensiero: non ho altra comprensione che la carne colta nei sensi per dire che solo ciò che muore comprende l’eternità. Entrambe vivono nella stessa medaglia. Spero che non si sia capito nulla, altrimenti significa che non ho minimamente sfiorato l’indicibile che aleggia e soffia dove vuole, il non detto che ogni parola possiede, che fa tremare ogni simbolo.
Come interagiscono o agiscono le tue letture sul testo? Come si percorre la letteratura nel momento in cui ci si approccia alla scrittura di poesie?
Ah, saperlo! Una cosa però posso dire: alcuni poeti mi dicono che la poesia è possibile e che quello che cerco nei miei testi da qualche parte esiste. Ecco più che un dizionario di modi di dire, di scrivere, è esattamente il contrario: aiuta a scartare il proprio chiacchiericcio. Che qualcuno possa dirmi che in qualche mio testo aleggi la scrittura dell’Achmatova o di Mujica, non aggiunge nulla al testo in sé, non aggiunge nulla alla lettura, credo. Che invece in qualche mio testo aleggi la frase: la poesia è possibile, entriamo; e che attraverso di me, si possa passare a leggere altra poesia, o i padri come Dante, Goethe e altri, ecco questo mi inviterebbe ad avere fiducia. Potrebbe essere un verso su migliaia, ma a volte a qualcuno serve quel sasso per guadare il torrente. La letteratura e la poesia però agiscono soprattutto su altri versanti. Io leggo prima come lettore che come scrittore. Ciò è principale rispetto alla lettura come bottega. Ci sono libri che cambiano il mio modo di vedere, di pensare, dicono che la vita è ancora possibile, che vale la pena e che è terribilmente bella. Che vale la pena fermarsi a guardare una fila di formiche che bucano il cosmo e il tempo. Come dice il mio prof. l’affascinato affascina e questo è tutto il segreto della scrittura. Ma imitare un innamoramento a volte non è facile. Innamorarsi dell’innamoramento sì.
Quanto hanno contribuito il pensiero di Maritain e S. Tommaso a te e alla tua scrittura e al modo che hanno di approcciarsi al reale?
Ho scoperto San Tommaso grazie a Maritan perché, in sintesi ero affascinata dal pensiero totale, cioè da chi affronta tutte le problematiche filosofiche, teologiche, pratiche. In pratica ero stanca di leggere pensieri su un dato aspetto della realtà (che problematizzato su tanti fronti) e desideravo percepire (almeno quello) la grande cattedrale. Nella percezione della realtà quindi credo che la principale influenza sia stata quella di non prenderla a pezzi ma di considerare i singoli pezzi come possibile parte di un tutto, senza escludere Dio, o un principio fondativo più forte della stessa idea di pianeta, cioè di materia sospesa a caso e piena di regole non casuali. Una causalità necessaria, meccanica. A caso è nato un mondo regolamentato. Mah. Non sopportavo la casualità di certo pensiero attribuita alla nascita del mondo e la voracità nello scovare regole in ogni settore sia cavalcando una visione biologica, sia cavalcando una visione anti-metafisica laica. Credo che, come possa stare stretta a chiunque una fisiologia dello stupore, così a me stava stretto pure uno stupore regolato da una spiritualità chimichesca, un aldilà meccanico, una terapia del dolore della mancanza di senso, liberata dalle proiezioni psicologiche di nota filosofia, ma ingabbiata in regole. Il mistero incatenato al suo essere mistero. Come ho detto per me è accettabile solo la testimonianza “lo spirito soffia dove vuole”. Maritain mi ha inoltre iniziato alle riflessioni sulla comprensione della poesia solo entro i confini della ragione logica, intuendo un preconscio dello spirito non freudiano, dal quale la poesia emerge come viaggio dentro la bellezza, non solo estetica, ma anche appunto spirituale. Indagine che è ancora in corso e che prosegue oltre Maritain intrecciando letture di libri che seguono quasi come l’odorato dei cani, gli incontri stranamente avvenuti davvero fra gli autori. Così è stato con Berdjaev, orizzonte ora ultimo delle mie ricerche.
Quale il rapporto tuo e dei tuoi testi con la poesia del maestro Luzi?
Non so a quanti possa interessare, ma su Luzi posso solo raccontare il mio incontro in via di Bellariva, incontro che nasceva dal desiderio di chiedere appunto al maestro un suo parere sul senso o meno di fare un libro di poesia. Erano circa passati una decina d’anni dalle mie prime prove di scrittura e mi mancava il coraggio di pubblicare. Oltre al coraggio volevo cercare di capire cosa fosse un libro di poesie, dal momento che ogni mio testo nasceva come unico e distinto. Non trovavo nessi, argomenti, fili rossi. Inoltre la mia domanda era radicale: ha senso continuare a scrivere? Da che cosa dipende? Era radicale e drammatica, la questione. Mancava l’ok del maestro, poiché non ero sicura per nulla dei miei testi, della loro bontà. Solo un poco potevo dire che erano frutto della necessità, ma non di una necessità meccanica, biologica. Una necessità, in un certo senso, libera. Per necessità libera intendo il magma che fuoriesce e che cerca di trovare pace solidificandosi. La libertà dell’animale che va a morire in un luogo preciso, dove la sua libertà sposa una istintiva bontà. L’ultimo esempio lo colgo dal capriolo libero, trovato solo sotto la pioggia e curato da mio cugino, e ritrovato morto nella sua stalla. La libertà è sempre un ritorno alle origini, a una terra meno fredda, una paglia preziosa. Ecco cercavo il senso della scrittura ponendomi una scelta radicale e mi dicevo: se Luzi mi risponderà che devo smettere di scrivere lo farò, pregustando tutto il dolore, dolore simile a quelle che invade una persona quando è costretta a lasciarne un’altra. Mi chiese: puoi percepire la realtà diversamente da come la vedi ora? No. Ecco o scrivendo o non scrivendo quella è la possibilità della poesia. Nessuno potrà impedirtelo. Poi sul mio lavoro tralascio. Ma trovai il coraggio di dare alla luce un piccolo primo libretto. Poi ho stranamente continuato, perdendo e ritrovando la poesia, come sempre capita. I suoi testi li ho letti e riletti tentato di partecipare soprattutto e in differita, alla questione Mallarmé, a quel tentativo d’altezza e di profondità drammatico. Un po’ il gioco dell’oca quando arrivati si ritorna al via, al punto di partenza. Iniziare dalla rosa e ricominciare sempre dalla rosa, perché in piedi da sola e senza vaso e radici non ci sta.
Tra il primo libro e gli altri c’è uno scarto circa la centralità riservata all’io all’interno dei testi e nell’intervista per il rubino hai affermato l’impossibilità e l’insensatezza di eliminare del tutto lo stesso dai testi. Quindi quando l’ego in poesia e l’esperienza personale, se lo fossero, potrebbero diventare deleteri?
Nel mio primo libro sì ho detto io tante volte e mi fu segnalato anche come malattia dell’ego, centralità dell’ego, masturbazione egocentrica etc. Che dire? Anticipo la risposta: ero da un lato attratta dal mio abisso ed ero anche l’autore di quello che scrivevo. E’ sbagliato cercare di conoscere l’abisso del cuore umano? Essere attratti dalla propria attenzione? Andiamo ora a prendere una lama e tentiamo di tagliare il punto esatto nel quale l’ego (negativo) si distingue da sé, dall’io positivo, dal cuore umano di cui è lecito parlare, come se non fosse il proprio, ma quello di qualcun altro. Non ultimo il mantra del permesso di parlare solo della propria esperienza, per rendere appunto veritiero ciò che si dice e non artefatto o campato nell’aria del ragionamento. Che confusione, lo so. In effetti separare tutto ciò che è unito nel nostro corpo (così pare) è impresa degna di medici legali mezzo sacerdoti. Anche quanto dice Maritain non è sempre chiaro. Ma vorrei solo citarlo brevemente senza ricadere nella teoria. Maritain distingue l’ego dal sé, l’uno deleterio come dici tu, l’altro autore di ogni percezione, specchio della realtà. Se non si avesse a cuore conoscere se stessi e il proprio abisso, non avrebbe credo senso indagare la realtà, parlarne. Siamo legati come le manette alle spalle. E da questo legame figliano i testi. A loro modo certo. In un testo c’è il naso della realtà e l’espressione dell’autore, il tono, il DNA. E qualcosa di noi che s’innamora di ciò di cui sta parlando o tentando di afferrare nei versi. Non si spiegherebbero gli affanni a cercare qualcosa dell’autore, della sua vita. Qualcosa che ci faccia scoprire come sia nata in lui la poesia e come sia stata coltivata, aiutata. Certo l’opera va distinta e non ci sono ricette per far nascere il talento o la genialità.
Come ho scritto da qualche altra parte (il discorso è lungo) la poesia non serve in realtà per realizzare se stessi a livello sociale, ma neppure a livello spirituale. Non è una piccola religione artigianale e non può rispondere alle domande di senso che tutti abbiamo. Semmai può amplificarle. Per noi occidentali non è neppure un surrogato di un sacramento, un sacramento laico con qualche tocco magico. Quindi chi usa la poesia per dire io, per realizzare se stesso, per certi aspetti potrebbe trovare quasi un nemico, un omicida di sé perché la poesia fa lo sgambetto, quando credi di stare in piedi. La poesia come stampella dell’ego è pericolosa, l’arte come indagine del cuore umano è arte. La poesia non sta in piedi da sola anche se i versi sono perfetti. Non è neppure possibile una scampagnata spirituale. La vera poesia è più un pericolo per l’ego che una medicina. “Non sono felice, ma ho la poesia” è una frase quasi grottesca. Se davvero la poesia potesse essere un grido e solamente quello, simile al grido migliore di una qualsiasi animale, ma vincolato alla natura umana, quindi un grido umano, sarebbe al massimo la possibilità di sentirsi, di sentire se stessi nel momento in cui si vive, sentire la nostra verticalità simile agli alberi, perpendicolari alla terra. Non mi è certo chiaro il nesso fra il sé e la poesia, neppure citando Buber potrei chiudere la ricerca su questo aspetto della scrittura. Ecco vorrei lasciare aperto il cerchio e rimandare l’argomento a quello che ho già tentato di scrivere di qua e di là.
Anche dovessi raggiungere il podio della realizzazione mediatica, la vera poesia, qualora mi arrivasse, mi toglierebbe lo sgabello in qualche verso. Magari si potesse lasciare solo l’opera, qualora ci fosse e andarsene o rimanere come spettatori anonimi, incappucciati, la cui biografia è interessante solamente in quanto biografia, storia di una vita, storia quindi di tutte le vite. Essere il popolo che legge la scrittura, come nella Bibbia, il popolo che partecipa al grande esodo e non colui che guarda e neppure crede alla propria scrittura, neppure sale sulla giostra da lui stesso creata. Il giostraio è già altrove e rimane il proprio ego davanti alla folla che ne pesta la e come la testa di un animale, fregandosene. La folla (il pubblico) non è la mutua.
Secondo te com’è cambiato il mondo della poesia nel tempo e quali errori le nuove generazioni fanno nell’approcciarsi alla disciplina?
Sento molta diffidenza e desiderio di autonomia. Mancano forse i padri, coloro che con bastone e carota educano, fanno crescere i segni di poesia. I padri non morali e neppure i padrini di nota eco sinistra, mancano proprio i riferimenti viventi, forse. Lo spingere l’acceleratore sulle pubblicazioni non porta a maggiore scambio o a una crescita artistica. E’ un po’ come mangiare il cornetto algida dal fondo. Il fondamento dell’arte, il cemento, non è la pubblicazione, il mettere in cassaforte la propria arte prima che sfugga. Annunciarla sottovoce con i social è rendersi forse sfigati, o mettersi un colletto da leopardi. Come ho già detto il pubblicare per salire sul titanic rende tutto più pesante e difficile da reggere. Un viaggio difficile, anche in terza classe. Il centro dell’arte non può essere una percepita movida letteraria, frustrante per chi non ne fa parte. Il centro drammatico dell’arte è sempre lì dove ti trovi davanti alla poesia che non riesci a scrivere. La nascita di un testo può essere anche una emozione social, ma è la propria stanza che si apre lo squarcio. Troppo retorico? Boh. Può essere, ma ritrovarsi nella movida letteraria, attendere la tarda ora in una strada che si svuota dove tutti i più furbi sono già andati a dormire è una sensazione così triste che riconosco essere più allettante dare credito alla scrittura privata. Ci pensa comunque la vita a portarti via, in un altro centro ventoso, in sedie di sale d’aspetto, primi davanti alle morti o secondi, come ho scritto in un testi e tristemente citandomi, più in basso di tutto. Più in basso, soprattutto, della poesia.
Importanti sono poi le amicizie vere, quelli che ti vogliono bene anche se non scrivi come Dante Alighieri. Insomma gli amici che non ti permettono di coltivare quell’ego per realizzarti, ai quali basta la tua presenza. I veri maestri divini. Mai come oggi c’è tanto bisogno di amicizia, di comunione spirituale e artistica, di parlarsi, di ascoltarsi. Il desiderio di tanti di essere letti (senza essere feriti) è in fondo un desiderio d’amore. Oggi i vecchi discorsi che accadevano nei caffè sono stati tirati su da una gru e spostati sui palchi dei festival, sono stati resi pubblici. Ma io credo occorra far scorrere le idee, far scorrere i testi prima nel sottosuolo, poi alla luce andranno coloro che, rimanendo ultimi nel tavolo prenotato e non avendo nulla da fare, scuotono la testa e vogliono capire meglio, confrontarsi, raccogliere ciò che è rimasto in piedi sul tavolo.
Originariamente tratto da https://paperstower.wordpress.com/2020/09/29/la-voce-dei-poeti-francesca-serragnoli/
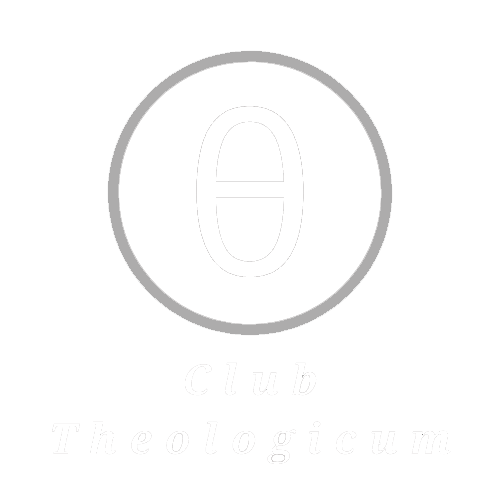

Lascia un commento