Preparazione
Il 25 gennaio 1959, meno di 100 giorni dopo la sua elezione, in un discorso in cui tracciava le linee generali del suo pontificato, papa Giovanni XXIII disse a un gruppo di cardinali riuniti a San Paolo fuori le Mura che intendeva tenere un sinodo diocesano per Roma e un concilio ecumenico per la Chiesa universale, i due eventi sarebbero stati seguiti da una riforma del Codice di Diritto Canonico. L’annuncio di un concilio ecumenico sorprese molti. Dopo il Concilio Vaticano I non si era più tenuto alcun concilio ecumenico e alcuni teologi ritenevano che le sue definizioni del primato e dell’infallibilità papali rendessero ormai superflui ulteriori concili ecumenici. Sia Pio XI che Pio XII avevano preso in considerazione l’idea di riconvocare il Vaticano I (che non era mai stato formalmente chiuso), ma alla fine nessuno dei due aveva portato avanti l’iniziativa.
In vari discorsi e messaggi degli anni successivi, Giovanni XXIII indicò i tre scopi generali che si riproponeva per il concilio: desiderava che questo fosse un’opportunità per promuovere il rinnovamento spirituale della Chiesa, tale da poterla rinvigorire e renderla più fedele alla volontà di Cristo; inoltre sperava che questo potesse promuovere una svolta pastorale della stessa in relazione alle mutate condizioni del mondo moderno; se questi due obiettivi fossero stati raggiunti, il concilio avrebbe anche dato un consistente contributo al ripristino dell’unità tra i cristiani.
La domenica di Pentecoste, il 17 maggio 1959, il Papa istituì una Commissione antepreparatoria presieduta dal cardinale Tardini, con mons. Pericle Felici come segretario, e composta da dieci ecclesiastici che ricoprivano importanti incarichi nella Curia romana. Questa commissione aveva il compito di consultare i vescovi del mondo, gli uffici della Curia e le facoltà teologiche e canoniche delle università cattoliche per avere consigli e suggerimenti su un’agenda conciliare, di tracciare le linee generali dei temi da discutere al concilio e di suggerire a chi demandare la preparazione del materiale per le deliberazioni conciliari. Ai vescovi e agli altri che furono consultati fu lasciata piena libertà di formulare suggerimenti in materia di dottrina, disciplina, attività pastorale e temi legati alla contemporaneità. Oltre il 75% di costoro risposero all’invito, tanto che le le loro proposte riempirono quindici grandi tomi. Le proposte erano assai variegate e riflettevano un’ampia gamma di prospettive teologiche e pastorali; c’era chi si opponeva a qualsiasi cambiamento e chi sperava che il concilio fosse un’opportunità per grandi riforme. C’è da dire comunque che la maggior parte dei vescovi furono piuttosto cauti nel formulare i propri suggerimenti, anche perché non era in effetti molto chiaro che cosa il pontefice si attendesse dal concilio in termini concreti.
Dal vasto materiale ricevuto la Commissione antepreparatoria selezionò 9.338 suggerimenti, che furono posti all’attenzione di coloro che erano ufficialmente impegnati nella preparazione del concilio. Man mano che la struttura della preparazione prendeva forma, questo materiale subì una radicale sfrondatura e fu presentato sotto forma di domande di approfondimento.
Nella Pentecoste del 5 giugno 1960, Giovanni XXIII annunciò come si sarebbe svolta la preparazione del concilio. Furono istituite dieci commissioni con il compito di redigere i testi da sottoporre all’esame del sinodo: (1) teologici (per le questioni di fede e di morale); (2) per i vescovi e il governo delle diocesi; (3) per la disciplina del clero e del popolo cristiano; (4) per i religiosi; (5) per la disciplina dei sacramenti; (6) per la liturgia; (7) per gli studi e i seminari; (8) per le chiese orientali; (9) per le missioni; (10) per l’apostolato dei laici. Inoltre, il papa istituì due segretariati: uno per le comunicazioni e l’altro per la promozione dell’unità dei cristiani. Fu anche istituita una Commissione centrale con il compito di supervisionare e coordinare il lavoro delle altre commissioni, di rivedere i testi da esse preparati e di raccomandarli al papa per l’agenda conciliare, nonché di redigere i regolamenti che avrebbero governato i lavori del concilio. Le dieci commissioni erano presiedute dai cardinali capi dei corrispondenti uffici della Curia romana, e nella maggior parte di esse figure curiali fungevano anche da segretari.
Il personale delle commissioni era composto da membri e consulenti, i primi con diritto di voto, i secondi con diritto di consulenza. Tra i membri e i consulenti, furono inclusi alcuni anche teologi i cui scritti erano stati nel decennio precedente ritenuti sospetti e, in alcuni casi, avevano anche cagionato misure disciplinari nei confronti dei loro autori. Tra questi c’erano Yves Congar, Henri de Lubac, Bernhard Haring e Karl Rahner. Nelle commissioni preparatorie non furono nominati né donne né laici.
Le commissioni si misero al lavoro sulla base delle domande proposte dalla Commissione antepreparatoria, pur potendo suggerire ulteriori domande. Il lavoro di preparazione soffrì di una mancanza di supervisione e dell’incapacità della maggior parte delle commissioni di collaborare su problemi comuni o correlati. La Commissione teologica, presieduta dal cardinale Alfredo Ottaviani, aggravò il problema insistendo sulla sua esclusiva responsabilità per le questioni dottrinali; non volendo entrare nel merito dei problemi pastorali pratici, si aspettava che tutte le altre commissioni le sottoponessero qualsiasi questione di dottrina. Come ulteriore espressione della sua concezione della propria sovranità, la Commissione teologica rifiutò di collaborare con altre commissioni e in particolare con il Segretariato per l’unità dei cristiani. Ad aggravare questa mancanza di coordinamento intervenne il fatto che molti interpretarono il segreto pontificio imposto sul lavoro delle commissioni come un divieto di condividere il proprio lavoro anche con i membri delle altre commissioni.
Le commissioni portarono davanti alla Commissione centrale un totale di 75 testi che vennero in seguito selezionati, alcuni rimandati alla riforma postconciliare del diritto canonico, altri fusi in un unico testo, così che alla fine un totale di 22 schemi furono considerati idonei alla discussione conciliare. I testi preparati dalle commissioni pastorali erano in genere molto semplici; non facevano altro che raccomandare cambiamenti per lo più minori nelle norme canoniche e disciplinari della Chiesa; c’erano pochissime prove che le commissioni avessero preso in considerazione le serie discussioni sociologiche e teologiche sull’attività pastorale che erano in corso da tre decenni. L’unica eccezione fu rappresentata dalla Commissione per la liturgia, i cui membri comprendevano molti dei più importanti studiosi del movimento liturgico; essi decisero di intraprendere seri studi storici e teologici sui vari argomenti affrontati e furono quindi in grado di sostenere con argomenti efficaci le loro raccomandazioni per una significativa riforma liturgica.
La Commissione teologica preparò otto testi: una nuova formula per la professione di fede, destinata all’apertura del concilio, e sette costituzioni: sulle fonti della rivelazione, sull’ordine morale, sulla difesa del deposito della fede, sulla castità, la verginità, il matrimonio e la famiglia, sulla Chiesa, sulla Beata Vergine Maria, sulla comunità delle nazioni e sull’ordine sociale. In generale, questi testi intendevano confermare con l’alta autorità del concilio gli orientamenti e le enfasi che avevano caratterizzato il magistero papale nel secolo e mezzo appena trascorso, in particolare come erano stati espressi nel Vaticano I, nei documenti antimodernisti Pascendi e Lamentabili e nell’enciclica Humani generis. Il loro tono generale era molto difensivo, sospettoso della maggior parte dei recenti movimenti di rinnovamento teologico nella teologia dogmatica e morale e negli studi biblici, e nel migliore dei casi indifferente alle implicazioni ecumeniche.
Durante il periodo preparatorio il Segretariato per l’unità dei cristiani, presieduto dal cardinale Augustin Bea, rappresentava un’idea diversa di ciò che il concilio avrebbe potuto fare e di come avrebbe potuto farlo. All’inizio questa ricevette dal papa il permesso di preparare testi per segnalare alle altre commissioni le dimensioni ecumeniche di vari argomenti. Quando i suoi sforzi per collaborare con la Commissione teologica furono respinti, iniziò a preparare testi che nelle intenzioni avrebbero dovuto essere portati direttamente all’attenzione del concilio. Alcuni dei testi del Segretariato riguardavano questioni prese in considerazione anche dalla Commissione teologica, tra cui la Parola di Dio, l’appartenenza alla Chiesa, l’autorità gerarchica e la libertà religiosa. Questi testi furono scritti con l’obiettivo di superare le incomprensioni della dottrina cattolica da parte degli altri cristiani, di esplorare con simpatia i loro punti di vista e di proporre modi di comprendere e affermare la dottrina cristiana che superassero le contrapposizioni polemiche.
Tutti i testi redatti dalle commissioni preparatorie furono sottoposti all’esame della Commissione centrale, composta da cardinali e arcivescovi di tutto il mondo, che si riunì in sei incontri tra il 12 giugno 1961 e il 20 giugno 1962. I membri di questa commissione non furono restii a criticare il materiale prodotto e le loro proposte di emendamento furono sottoposte a una sottocommissione, il cui lavoro doveva poi essere esaminato dall’intera Commissione centrale; il poco tempo a disposizione, però, non permise che si completasse quest’ultimo passaggio.
Con il motu proprio Appropinquante concilio (6 agosto 1962) Giovanni XXIII stabilì le norme che dovevano regolare lo svolgimento del concilio. Per la direzione delle congregazioni generali, in cui dovevano essere discusse e votate le proposte di decreti, istituì un consiglio di dieci presidenti, tutti cardinali, che dovevano supervisionare il dibattito e mantenere la disciplina, con uno di loro a presiedere quotidianamente le congregazioni stesse. Istituì anche dieci commissioni, che erano le stesse della fase preparatoria, anche se la prima fu ribattezzata Commissione per la dottrina della fede e della morale, e l’ultima era ora incaricata di questioni riguardanti non solo l’apostolato dei laici, ma anche del tema mass media e dello spettacolo. Al Segretariato per la promozione dell’unità cristiana, la Commissione tecnico-organizzativa e il Segretariato finanziario, all’ultimo minuto, il papa aggiunse un Segretariato per gli Affari straordinari che avrebbe esaminato nuove questioni proposte dai padri conciliari. Oltre al presidente, nominato dal papa, ogni commissione conciliare era composta da 24 membri, due terzi dei quali erano eletti dai padri e gli altri scelti dal papa stesso; ciò rappresentava un cambiamento rispetto al Vaticano I, dove tutti i membri delle commissioni conciliari erano stati eletti dall’assemblea. Il latino doveva essere usato nelle sessioni pubbliche e nelle congregazioni generali; nelle riunioni delle commissioni avrebbero potuto essere invece utilizzate anche le lingue moderne. Gli interventi dei singoli padri non dovevano durare più di dieci minuti. La maggioranza richiesta per l’approvazione di tutte le questioni, eccetto le elezioni, era di due terzi dei votanti. Alcune di queste disposizioni sarebbero state successivamente modificate alla luce dell’esperienza conciliare.
Il 23 luglio 1962, la Segreteria Generale del Concilio, con a capo l’arcivescovo Pericle Felici, inviò ai padri conciliari un primo volume contenente i testi che sarebbero stati discussi nella prima sessione del Concilio Vaticano II. Questo conteneva i seguenti testi: bozze di costituzioni dogmatiche sulle fonti della rivelazione, sulla difesa del deposito della fede, sull’ordine morale cristiano, sulla castità, sul matrimonio, sulla famiglia e sulla verginità, bozze di costituzioni sulla sacra liturgia e sui mezzi di comunicazione di massa, e una bozza di decreto sull’unità della Chiesa (che trattava delle Chiese cattoliche orientali). Non si sa perché tra la massa di materiale preparato siano stati scelti questi sette testi per l’agenda conciliare iniziale; un secondo volume sarebbe stato distribuito ai padri solo all’inizio di novembre.
L’obiettivo ecumenico del concilio si rifletteva negli inviti inviati alle principali Chiese e comunità cristiane. I loro rappresentanti erano autorizzati a partecipare non solo alle sessioni pubbliche ma anche alle congregazioni generali, ma non avevano diritto di voto o di parola; avrebbero comunque potuto far conoscere le loro opinioni alle commissioni attraverso il Segretariato per l’unità dei cristiani e i contatti personali con i padri conciliari. Fu una grande delusione che la maggior parte delle Chiese ortodosse non fosse rappresentata alla prima sessione, ma una decisione presa in un incontro pan-ortodosso a Rodi nel 1961 aveva stabilito una risposta comune; alla vigilia del Concilio, tuttavia, il patriarcato di Mosca ruppe gli indugi e decise di inviare dei rappresentanti. I rappresentanti del patriarca di Costantinopoli non parteciperanno al Concilio fino alla terza sessione. La rappresentanza ecumenica al Concilio aumentò di anno in anno; 17 confessioni ortodosse e protestanti erano rappresentate da 35 delegati-osservatori e ospiti nel primo periodo, mentre nel quarto c’erano in totale 93 appartenenti 28 gruppi cristiani diversi.
L’annuncio del concilio e gli anni della sua preparazione avevano creato un ampio interesse sia all’interno che all’esterno della Chiesa cattolica. Apparvero numerose indagini storiche e studi sui venti concili ecumenici precedenti, oltre a monografie sui temi che probabilmente sarebbero stati discussi al Vaticano II, in particolare nei settori della liturgia e dell’ecclesiologia. Vennero pubblicati sondaggi sulle aspettative e sui desideri dei cattolici riguardo al Concilio e diversi autori pubblicarono proposte per un programma di riforme.
Nella primavera del 1962, alcuni importanti membri della Commissione Centrale, tra cui i cardinali Suenens (arcivescovo di Malines-Bruxelles) e Leger (arcivescovo di Montreal) e l’arcivescovo Dennis Hurley (Durban, Sudafrica), scrissero a papa Giovanni per esprimere le loro perplessità in merito alla possibilità di raggiungere gli obiettivi che il concilio si proponeva sulla base dei testi proposti. Tali timori si diffusero man mano che il carattere dei testi ufficiali cominciò ad essere maggiormente noto. Si temeva che il concilio, che si prevedeva durasse non più di due sessioni, avrebbe comportato poco più che un’omologazione dei documenti presentati ai padri.
Svolgimento
Il Concilio Vaticano II si riunì in quattro periodi: dall’11 ottobre all’8 dicembre 1962; dal 29 settembre al 4 dicembre 1963; dal 14 settembre al 21 novembre 1964; e dal 14 settembre all’8 dicembre 1965.
Nei suoi quattro anni di durata, al Vaticano II parteciparono complessivamente 3.058 padri, di gran lunga il numero più alto nella storia dei concili ecumenici. Oltre ai 129 superiori generali degli ordini religiosi clericali, i prelati provenienti dall’Europa furono 1.060 (36%), dal Sud America 531 (18%), dal Nord America 416 (14%), dall’Asia 408 (14%), dall’Africa 351 (12%), dall’America Centrale 89 (3%) e dall’Oceania 74 (3%). La partecipazione degli aventi diritto fu altalenante. La partecipazione fu massima durante il primo (84,34%) e il quarto (84,88%) periodo; minore nel secondo periodo (82,34%) e nel terzo (80,23%). Bisogna tener conto però del fatto che a molti prelati residenti nei paesi del blocco socialista fu impedito di partecipare al concilio dai governi degli stessi.
Primo periodo. Il primo è più complicato dei quattro periodi del concilio si aprì con una cerimonia solenne alla quale parteciparono i rappresentanti di 86 governi e organismi internazionali. Nel suo discorso di apertura, Giovanni XXIIII si disse in disaccordo con “quei profeti di sventura che prevedono sempre disastri” e raccomandò ai padri di considerare se Dio non stesse offrendo nuove opportunità alla Chiesa. Voleva che il concilio non si limitasse a difendere il patrimonio della fede, ma che considerasse come comprenderlo e presentarlo ai contemporanei; a tal fine distinse tra la sostanza della fede e il modo in cui questa può essere articolata, e sollecitò un’attenzione particolare alla pastorale. Di fronte agli errori consigliava ai padri di evitare le condanne e di dare invece una dimostrazione positiva della validità dell’insegnamento della Chiesa. Sottolineò il dovere di lavorare attivamente per la realizzazione dell’unità con gli altri cristiani e con i non cristiani. A chi conosceva il materiale preparatorio, sembrò che il papa stesse dichiarando la sua insoddisfazione per gli schemi ufficiali e proponesse al concilio di adottare un approccio diverso.
La prima congregazione generale (13 ottobre 1962) ebbe conseguenze permanenti per il concilio, perché invece di procedere immediatamente, come era stato programmato, all’elezione dei 16 membri di ogni commissione, su mozione del cardinale Achille Lienart, vescovo di Lille, e del cardinale Josef Frings, arcivescovo di Colonia, si aggiornò dopo pochi minuti per dare più tempo alla consultazione tra i vescovi dei vari paesi o regioni. Le conferenze episcopali nazionali o regionali decisero quindi di raccomandare uno o due candidati del proprio numero per ogni commissione; e nella seconda congregazione generale (16 ottobre), prima che i padri esprimessero il loro voto, fu distribuito un elenco composito di tutti questi candidati. In questo modo le commissioni diventavano più rappresentative dell’intera assemblea e non si limitavano a perpetuare la mentalità delle commissioni preparatorie, che erano state largamente dominate da esponenti della Curia romana e che, si temeva, avrebbero difeso le posizioni espresse nei documenti preparatori, posizioni su cui molti dei padri dissentivano. Una certa continuità fu comunque assicurata dalla nomina da parte del papa a presidenti delle commissioni conciliari degli stessi cardinali curiali che avevano presieduto le corrispondenti commissioni preparatorie.
Nel corso di questo primo periodo il concilio discusse gli schemi sulla liturgia, sulle fonti della rivelazione, sui mass media, sull’unità della Chiesa e sulla Chiesa. Si discusse animatamente sulle proposte dello schema sulla liturgia relative ad un maggiore uso delle lingue correnti, di una pratica più comune della comunione sotto entrambe le specie e della concelebrazione, e di una maggiore libertà e autorità in materia liturgica per le singole conferenze episcopali. Il lungo dibattito si concluse con una votazione sui principi generali enunciati nella bozza e la stragrande maggioranza dei padri (2.162 contro 46) si dimostrò pronta a intraprendere una significativa riforma della Chiesa.
Il secondo importante dibattito riguardò lo schema sulle fonti della rivelazione che si concentrava su due questioni: il rapporto tra Scrittura e Tradizione e il valore del metodo storico-critico in relazione all’interpretazione della Bibbia. Il testo fu aspramente criticato per il suo tono negativo e la mancanza di sensibilità ecumenica e pastorale, per aver risolto prematuramente la questione legittimamente dibattuta relativa al fatto se tutte le verità rivelate fossero contenute nella Scrittura e per il giudizio sostanzialmente negativo verso l’esegesi storico-critica, che avrebbe tagliato le gambe ad ogni futuro contributo significativo da parte cattolica alle scienze bibliche. I difensori del testo sostenevano che la questione dogmatica era stata risolta al Concilio di Trento e dal successivo insegnamento comune e che la fede era messa in pericolo da libri e articoli che mettevano in dubbio il carattere storico dell’Antico e del Nuovo Testamento. Si votò se interrompere il dibattito o se continuare con la discussione dei singoli capitoli. Sebbene il voto per l’interruzione (1.368 a 822) fosse di poco inferiore alla maggioranza dei due terzi, il Papa, per evitare un dibattito prolungato e probabilmente infruttuoso, intervenne, interrompendo la discussione e rimandando il testo a una commissione speciale sotto la presidenza congiunta dei cardinali Ottaviani e Bea perché fosse riscritto. Era ormai chiaro che una maggioranza sostanziale dei padri desiderava comporre testi diversi per orientamento e finalità da quelli proposti dalla Commissione teologica, e che il papa li avrebbe appoggiati.
Ora che il concilio aveva chiaramente dimostrato i suoi interessi pastorali e dottrinali, il resto del primo periodo fu un po’ deludente. Alcuni giorni furono comunque dedicati alla discussione preliminare dello schema sulla Chiesa, comunemente considerato come il fulcro attorno a cui l’intero concilio avrebbe dovuto ruotare. Il testo ufficiale fu accolto da un notevole dissenso e si capì, anche senza una votazione formale, che anch’esso avrebbe dovuto essere sostanzialmente rivisto. Del resto, questo sarebbe stato il destino di tutti gli schemi preparati. Il 6 dicembre 1962 fu annunciato che il papa aveva nominato una Commissione di coordinamento, presieduta dal cardinale Amleto Cicognani, il cui compito sarebbe stato quello di rivedere le bozze dei testi preparati per il concilio e, alla luce degli obiettivi dello stesso così come erano emersi dalle intenzioni del papa ed erano stati ratificati dalle votazioni fino a lì effettuate, decidere quali dovevano essere mantenuti nell’agenda conciliare, quali potevano essere lasciati per le decisioni post-conciliari, e quali modifiche di contenuto o di metodo e tono dovevano essere apportate. Questa “supercommissione” ridusse rapidamente i testi a 17, l’ultimo dei quali era un nuovo schema, sostenuto in particolare dal cardinale Suenens, per affrontare il tema della presenza della Chiesa nel mondo moderno. Durante l’intersessione, le commissioni conciliari intrapresero quella che è stata definita una “seconda preparazione” del Vaticano II.
Il primo periodo si concluse senza aver approvato un solo schema, ma le decisioni prese in esso determinarono l’orientamento dell’intero corso del Concilio Vaticano II. Le persone e gli scopi che avevano largamente dominato la preparazione del concilio erano stati sostituiti; nuovi leader avrebbero ora perseguito obiettivi largamente ignorati durante la fase preparatoria.
Con la morte di Giovanni XXIII, il 3 giugno 1963, il concilio e tutte le attività ad esso collegate furono automaticamente sospese. Ma il giorno dopo la sua elezione (22 giugno), papa Paolo VI promise che il concilio sarebbe stato ripreso e che avrebbe perseguito gli obiettivi fissati dal suo predecessore. Cinque giorni dopo fissò la data di apertura del secondo periodo per il 29 settembre.
Secondo periodo. Prima che i padri si riunissero nuovamente, Paolo VI pubblicò un’edizione riveduta dell’Ordo Concilii oecumenici Vaticani II celebrandi per correggere alcuni difetti di organizzazione e di procedura manifestati nel primo periodo e per accelerare i lavori e garantire la libertà dei partecipanti. Abolì la Segreteria per gli Affari Straordinari e ampliò a 12 membri il Consiglio di Presidenza, che avrebbe avuto il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle regole e di risolvere eventuali dubbi e rimuovere le difficoltà. Nominò inoltre quattro cardinali Agagianian, prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, Lercaro, arcivescovo di Bologna, Dopfner, arcivescovo di Monaco e Frisinga, e Suenens, arcivescovo di Malines-Bruxelles, come moderatori, stabilendo che si sarebbero alternati nella direzione delle discussioni nelle congregazioni generali. Il papa apportò diverse modifiche anche alle regole procedurali, come la riduzione al 50% più uno della maggioranza richiesta per il rifiuto o il rinvio di uno schema o di una parte di esso e la possibilità per un padre conciliare di parlare anche a nome di altri.
Per il miglioramento e l’ampliamento dei servizi giornalistici, sui quali c’erano state molte lamentele durante il primo periodo, Paolo VI nominò una Commissione per la stampa presieduta dall’abate Martin J. O’Connor. Il papa aumentò il numero di osservatori cristiani non cattolici invitati al concilio, tanto che nel secondo periodo ne furono presenti 31 in più rispetto al primo. Giovanni XXIII aveva invitato un laico cattolico, Jean Guitton, all’ultima parte del primo periodo; Paolo VI aveva previsto la presenza di diversi uditori laici alle congregazioni generali e la loro assistenza alle commissioni; oltre a Guitton, all’inizio del nuovo periodo furono accolti altri dieci laici di vari paesi, per lo più rappresentanti di organizzazioni cattoliche internazionali.
Nella sessione pubblica che aprì il secondo periodo, il 29 settembre 1963, Paolo VI tenne un discorso in cui sottolineò la natura pastorale dell’assemblea e ne specificò i quattro scopi: definire meglio la nozione di Chiesa, specialmente per quanto riguardava la posizione dei vescovi; rinnovare la Chiesa; promuovere il ristabilimento dell’unità tra tutti i cristiani (chiese che i non cattolici perdonassero ai cattolici le loro colpe negli scismi e condonassero le ferite inferte ai cattolici); e avviare un dialogo con il mondo contemporaneo.
Le discussioni conciliari iniziarono con la revisione dello schema sulla Chiesa. Il 30 ottobre i moderatori, con una procedura non prevista dall’Ordo, misero ai voti per la guida della Commissione dottrinale cinque proposizioni contenute sostanzialmente nel terzo capitolo dello schema. Quattro di esse riguardavano la sacramentalità dell’episcopato e il suo carattere collegiale; la quinta riguardava il ripristino del diaconato come ordine permanente. Tutte e cinque le proposizioni ottennero maggioranze superiori ai due terzi, eliminando così ogni dubbio sulla tendenza sostanzialmente riformatrice del concilio. Ma il carattere “irregolare” delle votazioni sarebbe stato evocato più volte in seguito per metterne in dubbio la validità.
Sempre in relazione allo schema sulla Chiesa, un’altra divisione tra i padri si manifestò relativamente alla questione se lo schema sulla Beata Vergine Maria dovesse essere un testo separato o essere incorporato nello schema sulla Chiesa. Dopo un dibattito appassionato, la questione fu messa ai voti il 29 ottobre e con il margine più stretto di tutte le deliberazioni conciliari (1.114 a 1.074) l’assemblea decise di incorporarlo nella costituzione sulla Chiesa.
Durante la discussione dello schema sui vescovi e sul governo delle diocesi (5-15 novembre), si verificò uno dei rari scontri del Concilio, quando il cardinale Frings criticò apertamente i metodi del Sant’Uffizio, mentre il cardinale Ottaviani, suo segretario, li difese con veemenza. I primi tre capitoli dello schema sull’ecumenismo vennero discussi (18 novembre-2 dicembre) e approvati a condizione che venissero rivisti, ma, per la delusione di molti padri, ogni azione sul quarto capitolo (sull’atteggiamento della Chiesa nei confronti dei non cristiani e in particolare degli ebrei) e sul quinto (sulla libertà religiosa) venne rinviata al terzo periodo, presumibilmente per mancanza di tempo per una riflessione matura.
Il 21 novembre il pontefice annunciò che il numero dei membri di ciascuna commissione sarebbe stato portato a 30. Dopo che le conferenze episcopali ebbero nominato nuovamente dei candidati, il 28 novembre i padri elessero la maggior parte dei nuovi membri e il papa nominò gli altri. Le commissioni elessero poi un nuovo vicepresidente e un segretario. Lo scopo dichiarato di questi cambiamenti era quello di accelerare i lavori delle commissioni, ma sembra che fossero anche intesi ad indurre alcune commissioni recalcitranti ad allinearsi con i desideri della maggioranza conciliare.
Durante la cerimonia di commemorazione della conclusione del Concilio di Trento (3 dicembre), Paolo VI rese noto il motu proprio Pastorale munus (30 novembre), con il quale concedeva o dichiarava di ripristinare alcune facoltà e alcuni privilegi dei vescovi, molti dei quali erano stati proposti in un’appendice allo schema sui vescovi e sul governo delle diocesi.
Il 4 dicembre si tenne la sessione pubblica conclusiva del secondo periodo. I padri approvarono definitivamente la costituzione sulla liturgia con un voto di 2.147 a 4 e, con un voto di 1.980 a 164, il decreto sui mezzi di comunicazione. Contro quest’ultimo era stata sollevata all’ultimo momento l’obiezione che non avrebbe risposto alle aspettative dei cristiani e avrebbe compromesso l’autorità del concilio. Il papa, con una formula che sottolineava la sua unione con gli altri padri conciliari, approvò e promulgò i due testi. Il 25 gennaio 1964 emanò il motu proprio Sacram Liturgiam con il quale istituì una commissione per l’attuazione della costituzione sulla liturgia.
Nel suo discorso conclusivo Paolo VI ringraziò i padri che avevano contribuito alle spese del concilio o avevano aiutato i loro fratelli bisognosi, osservò che il concilio era stato caratterizzato da un lavoro assiduo e dalla libertà di espressione, espresse la speranza che potesse completare i suoi lavori in un terzo periodo e annunciò il suo prossimo pellegrinaggio in Terra Santa.
Durante l’intervallo tra il secondo e il terzo periodo i padri furono nuovamente invitati a presentare ulteriori commenti sul lavoro incompiuto, dando così modo alle commissioni di rivedere ulteriormente gli schemi. Su indicazione della Commissione di coordinamento e in accordo con i desideri del papa stesso, esse ridussero alcuni temi, in particolare quelli sui sacerdoti, i religiosi, l’educazione al sacerdozio, l’attività missionaria, il matrimonio e l’educazione cattolica, a una serie di principi brevi e basilari sui quali ci si aspettava che i padri si accordassero facilmente e rapidamente, e senza discussioni pubbliche, nel terzo periodo; l’articolazione più completa e l’attuazione di questi principi potevano essere lasciate agli organismi postconciliari. Questa riduzione dell’agenda conciliare, nota come “piano Dopfner”, era stata pensata per garantire che il concilio potesse terminare i suoi lavori con la terza sessione, e a questo scopo furono apportate modifiche anche alle procedure conciliari per evitare ripetizioni e accelerarne le decisioni.
Poco prima dell’apertura del terzo periodo, il papa annunciò che le donne si sarebbero unite ai laici come uditori del concilio. Tra il numero accresciuto di delegati-osservatori, per la prima volta, c’erano anche i rappresentanti del patriarcato di Costantinopoli.
Terzo periodo. Papa Paolo VI aprì il terzo periodo il 14 settembre 1964, con una sessione pubblica in cui concelebrò la messa con 24 padri conciliari, una prima espressione conciliare delle riforme concrete approvate nella costituzione sulla liturgia alla fine del secondo periodo. Le discussioni conciliari iniziarono con i capitoli dello schema sulla Chiesa non ancora approvati in congregazione generale e poi con successive votazioni sugli otto capitoli emendati. Nella discussione del capitolo sulla Beata Vergine Maria, il dibattito si concentrò sull’opportunità di attribuirle i titoli di “Mediatrice” e “Madre della Chiesa”. Grande interesse suscitarono le votazioni sul terzo capitolo, sulla costituzione gerarchica della Chiesa con particolare riferimento ai vescovi. La disputa sul rapporto tra primato papale e collegialità episcopale non si era attenuata, e infatti proprio alla vigilia del terzo periodo Paolo VI aveva ricevuto una nota confidenziale da parte di eminenti cardinali e capi di ordini religiosi che lo pregavano di non permettere che si votasse l’insegnamento del capitolo e lasciavano intendere, non molto velatamente, che se non avesse agito in tal senso, si sarebbe reso colpevole di sperperare l’autorità del suo ufficio. Dopo la lettura all’assemblea di quattro relazioni formali sul capitolo, si procedette alla votazione e i voti furono in gran parte favorevoli alle principali questioni in discussione.
Seguì la discussione sullo schema sull’ufficio pastorale dei vescovi, il cui avanzamento fu però ostacolato dalla necessità di attendere i risultati della votazione sullo schema sulla Chiesa. Gli schemi sulla libertà religiosa e sugli ebrei, che originariamente facevano parte dello schema sull’ecumenismo, dovevano ora diventare documenti distinti; il dibattito su di essi fu vigoroso e segnato da preoccupazioni sia teologiche che politiche. Il testo sulla libertà religiosa fu aspramente criticato da alcuni per essersi allontanato dalla tradizionale insistenza della Chiesa sui diritti unici della vera religione; chi lo difese addusse l’argomento che questo era indispensabile per fornire alla Chiesa uno strumento atto ad affrontare i recenti sviluppi delle realtà politiche, a rispettare la dignità e la libertà delle persone ed a preparare il terreno per un serio e fruttuoso dialogo ecumenico e interreligioso. Lo schema sul rapporto della Chiesa con gli ebrei continuò a ricevere critiche a causa delle conseguenze politiche che si temeva avrebbe avuto per i cristiani in Medio Oriente. Furono discussi anche un testo rivisto sulla divina rivelazione e uno schema sull’apostolato dei laici. All’inizio di ottobre lo schema rivisto sull’ecumenismo fu sottoposto a una serie di votazioni e approvato.
L’opposizione al piano Dopfner e a una rapida chiusura del concilio crebbe durante le prime settimane del terzo periodo e si manifestò quando i cosiddetti “schemi minori”, drasticamente ridotti, furono presentati ai padri. Il 12 ottobre fu presentato al concilio uno schema rivisto di 12 proposizioni “sulla vita e il ministero dei sacerdoti”, che fu attaccato da molti padri come inadeguato, superficiale, insignificante e deludente, e con un voto di 930 contro 1.199 fu rimandato alla commissione competente per essere completamente riformulato. La discussione dello schema sull’attività missionaria della Chiesa fu avviata dallo stesso Paolo VI, ma nonostante il suo giudizio favorevole, la maggior parte degli intervenuti lo ritenne insoddisfacente per la sua brevità ed essenzialità, e su proposta della commissione i padri, con un voto di 1.601 contro 311, lo rimandarono indietro per una completa riscrittura. Anche lo schema di 19 proposizioni sul rinnovamento della vita religiosa fu criticato, ma fu approvato con uno stretto margine (1.155 a 882) a condizione che fosse ampiamente modificato per tenere conto delle migliaia di riserve espresse. Lo schema di 22 proposizioni sull’educazione al sacerdozio fu accolto più favorevolmente ed fu sostanzialmente adottato. Lo schema sull’educazione cristiana, sviluppato a partire dall’inadeguato schema precedente di proposizioni sulle scuole cattoliche, fu sostanzialmente approvato nonostante 419 voti a sfavore. Fu discusso un breve documento sul sacramento del matrimonio, destinato alla guida della commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, e con una specifica votazione i padri accettarono la proposta dei moderatori di sottoporre lo schema al papa perché agisse in accordo con quanto era venuto fuori dalle discussioni conciliari.
Si discusse anche lo schema sulle Chiese cattoliche orientali e l’atteso schema di costituzione sulla Chiesa nel mondo di oggi, comunemente chiamato Schema 13 dal numero del suo posto nell’ordine del giorno. Il dibattito su quest’ultimo si concentrò soprattutto sulla metodologia dello schema, sul fatto se esso distinguesse e mettesse in relazione correttamente gli ambiti del naturale e del soprannaturale, e sull’opportunità che un concilio affrontasse le questioni estremamente contingenti discusse nelle appendici dello schema. I padri furono ammoniti perché evitassero di discutere del tema della contraccezione artificiale, che il papa aveva riservato allo studio di un gruppo speciale di esperti clericali e laici e al suo giudizio finale.
Quattro eventi negli ultimi giorni del terzo periodo causarono una reazione così severa da parte di alcuni padri conciliari che si parlò di “settimana nera”. Poiché una minoranza persisteva nelle sue obiezioni al terzo capitolo dello schema sulla Chiesa, il papa ordinò che una “nota esplicativa” fosse premessa alla spiegazione della Commissione dottrinale sulle revisioni finali; redatto per placare i timori della minoranza, questo testo voleva fornire l’interpretazione autorevole della dottrina contenuta nel terzo capitolo. Sebbene al concilio non fu mai data la possibilità di discutere o approvare questa nota, essa riuscì nel suo intento e nella votazione del 17 novembre solo 47 padri su 2.146 si opposero al testo.
Il 20 novembre, il testo rivisto sul rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane fu approvato con la clausola che gli emendamenti raccomandati sarebbero stati presi in considerazione. Lo schema rivisto sulla libertà religiosa subì un destino diverso. Distribuito ai padri il 17 novembre, secondo la decisione dei moderatori, doveva essere votato due giorni dopo. Poiché il nuovo schema differiva notevolmente per struttura, lunghezza e argomentazione dal testo discusso all’inizio del periodo, alcuni padri chiesero più tempo per poterlo studiare e meditare; per accontentarli, i moderatori e i presidenti decisero di fare una votazione preliminare per determinare se i padri volessero o meno procedere subito alla votazione prevista. Ma il giorno stabilito (19 novembre) il cardinale Tisserant, a nome dei presidenti, annunciò che non si sarebbe proceduto alla votazione in quel periodo. Tra forti sentimenti di delusione e di risentimento, una petizione urgente per un voto immediato, redatta dai vescovi statunitensi, fu fatta circolare nella sala del concilio e fu firmata da 441 padri (e successivamente da altre centinaia); fu poi presentata a Paolo VI dai cardinali Albert Meyer, arcivescovo di Chicago, Joseph Ritter, arcivescovo di St. Louis, e Paul Leger, arcivescovo di Montreal. Il papa confermò la decisione di rimandare la votazione con la motivazione che l’Ordo richiedeva più tempo, ma promise che lo schema sulla libertà religiosa sarebbe stato il primo punto all’ordine del giorno del quarto periodo.
Lo stesso giorno, furono distribuite ai padri 19 modifiche, introdotte all’ultimo momento per mandato papale nello schema sull’ecumenismo dal Segretariato per l’unità dei cristiani, che furono accolte il giorno successivo nella votazione finale sull’intero schema, con l’alternativa di respingere il documento nella sua interezza. Le modifiche avevano lo scopo di chiarire il testo, ma molte di esse furono ritenute offensive per e dai protestanti.
Nella sessione pubblica che concluse il terzo periodo, Paolo VI celebrò la messa con 24 concelebranti. Poi i padri approvarono la costituzione sulla Chiesa (2.151 a 5), il decreto sulle Chiese cattoliche orientali (2.110 a 39) e il decreto sull’ecumenismo (2.137 a 11), e il papa li promulgò. Nel discorso conclusivo il pontefice, dopo aver espresso il suo compiacimento per la dottrina sull’episcopato e sulla Chiesa in generale, proclamò di propria autorità Maria “Madre della Chiesa”, cioè di tutti i fedeli e di tutti i pastori. Il concilio aveva seguito il consiglio della Commissione dottrinale, rifiutando di attribuirle esplicitamente questo titolo e accontentandosi di presentare l’idea in termini equivalenti. Molti considerarono l’atto del papa come volto a riaffermare la sua autorità come distinta da quella del concilio.
Quarto periodo. Paolo VI aprì il quarto e ultimo periodo del concilio in una sessione pubblica il 14 settembre 1965, durante la quale concelebrò nuovamente la messa con 24 padri. Annunciò che avrebbe istituito (con il motu proprio Apostolica sollicitudo, datato 15 settembre) un Sinodo dei Vescovi, come aveva promesso in precedenza e come richiesto dai padri nello schema, ancora incompiuto, sull’ufficio pastorale dei vescovi; in questo modo la stretta collaborazione tra il papa e i vescovi avrebbe potuto continuare a giovare alla Chiesa anche dopo la fine del concilio.
Dei 16 documenti finali del Vaticano II, 11 furono completati, approvati e promulgati in sessioni pubbliche durante il quarto periodo; cinque testi furono promulgati il 15 ottobre, due il 18 novembre e quattro il 7 dicembre. Il ritmo degli sviluppi fu estremamente rapito e, per accelerare le cose, le opportunità per i vescovi di intervenire oralmente in aula furono ulteriormente ridotte rispetto al terzo periodo.
Come promesso dal papa, lo schema sulla libertà religiosa fu il primo ad essere discusso e, nonostante la strenua opposizione di alcuni, il 21 settembre in una votazione preliminare una maggioranza di 1.997 contro 224 lo accettò come base per un testo definitivo. Con alcune modifiche dell’ultimo minuto da parte del papa, il testo fu approvato il 15 ottobre con un voto di 1.954 a 249.
Lo schema sulla Chiesa nel mondo moderno era stato notevolmente ampliato con l’inclusione delle appendici alla bozza precedente. Su questo testo sorsero divergenze tra i progressisti: alcuni padri, soprattutto tedeschi, sostenevano che fosse troppo positivo, che trascurasse le realtà del peccato e che confondesse gli ambiti del naturale e del soprannaturale. I vescovi e i teologi francofoni ne difendevano l’approccio incarnazionista. Alcuni furono contrariati dal fatto che il testo non si esprimesse in modo più deciso nella sua sezione relativa alla guerra e alla pace. Questa sezione fu criticata anche, ma su basi quasi opposte, da alcuni vescovi statunitensi, in quanto ignorava il ruolo di deterrenza svolto dalle armi nucleari e implicava una critica alle politiche di difesa dell’Occidente. Ci furono alcune controversie anche in merito alle sezioni sul matrimonio e sul rapporto tra i suoi fini e sulla regolamentazione delle nascite. Un certo numero di vescovi fu inoltre irritato dal fatto che non fosse stata tenuta in considerazione l’idea di esprimere una netta condanna del comunismo. Il 6 dicembre lo schema fu approvato con un voto di 2.111 contro 251.
Lo schema rivisto sulla divina rivelazione continuò a essere oggetto di dibattito, in particolare sulla questione del rapporto tra Scrittura e Tradizione, sull’inerranza e sul carattere storico dei Vangeli. Gli interventi dell’ultimo minuto del papa ridussero l’opposizione al testo e questo fu approvato il 29 ottobre con un voto di 2.081 contro 27.
Tutti gli altri testi passarono attraverso le fasi finali della loro rielaborazione e approvazione senza grandi controversie: gli schemi sull’ufficio pastorale dei vescovi, sul rinnovamento della vita religiosa, sulla formazione sacerdotale, sull’educazione cristiana, sul rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane, sull’apostolato dei laici, sull’attività missionaria della Chiesa, sul ministero e la vita dei sacerdoti.
Il 7 dicembre, il giorno prima della chiusura del concilio, Paolo VI e il patriarca Atenagora I, al fine di superare gli attriti che impedivano una riconciliazione tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, espressero il loro rammarico per le reciproche scomuniche del 1054 e per le parole offensive, i rimproveri infondati e i gesti riprovevoli che avevano accompagnato quegli atti da entrambe le parti. Espressero inoltre il desiderio di rimuovere il ricordo di quegli eventi dal cuore della Chiesa e di consegnarli all’oblio. Infine, deplorarono gli incidenti spiacevoli precedenti e successivi che, sotto l’influenza di vari fattori tra cui la mancanza di comprensione e fiducia reciproca, avevano condotto nove secoli prima alla rottura effettiva della comunione ecclesiale.
L’ultima sessione pubblica del concilio si tenne all’aperto, davanti alla Basilica di San Pietro, l’8 dicembre 1965. Dopo una messa celebrata dal solo pontefice, fu letta una serie di messaggi al mondo, composti in francese: ai governanti, agli studiosi, agli artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri e ai malati, ai giovani. Fu poi letto dal segretario generale il breve apostolico In Spiritu Sancto che ordinava la chiusura del concilio e intonate le acclamazioni tradizionali dei concili ecumenici, mentre i padri professarono la loro obbedienza ai decreti conciliari.
Per far conoscere ai fedeli gli insegnamenti del concilio e stimolarli all’accettazione dei suoi decreti, per incitarli all’auspicato rinnovamento spirituale nella vita privata, domestica, pubblica e sociale e alla gratitudine a Dio per il concilio, e per sviluppare in loro il sentimento e la consapevolezza della Chiesa, Paolo VI, con la costituzione apostolica Mirificus eventus (7 dicembre 1965), proclamò un giubileo straordinario da celebrarsi in tutte le diocesi del mondo dal 1 gennaio al 29 maggio (Pentecoste) del 1966. Con il motu proprio Integrae servandae (7 dicembre 1965) cambiò il nome del Sant’Uffizio in Congregazione per la Dottrina della Fede e ne modificò le procedure. Poi, con il motu proprio Finis concilii (11 gennaio 1966) istituì le commissioni post-conciliari per (1) i vescovi e il governo delle diocesi, (2) i religiosi, (3) le missioni, (4) l’educazione cristiana e (5) l’apostolato dei laici, tutte composte dagli stessi presidenti, membri e segretari delle corrispondenti commissioni conciliari e assistite da esperti scelti appositamente tra i periti conciliari. Istituì anche una nuova commissione centrale con lo scopo di supervisionare il lavoro delle altre cinque commissioni e di interpretare i documenti del concilio. Infine, confermò l’esistenza permanente dei tre segretariati per la promozione dell’unità dei cristiani, per le religioni non cristiane e per i non credenti.
Adriano Virgili
Alcuni riferimenti bibliografici:
Pietro Palazzini (a cura di), Dizionario dei concili, Roma, Città Nuova, 1963-1968, VI Voll.
Giuseppe Alberigo (a cura di), Decisioni dei concili ecumenici, Torino, UTET, 1978
Giuseppe Alberigo (a cura di), Storia del Concilio Vaticano II, Bologna, Il Mulino, 2013, V Voll.
Pierre-Thomas Camelot, Paul Christophe, Francis Frost, I concili ecumenici, Brescia, Queriniana, 2001
Klaus Schatz, Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali, Bologna, EDB, 2012
Giovanni Vian (a cura di), L’età contemporanea (secoli XIX-XXI), Roma, Carocci, 2015
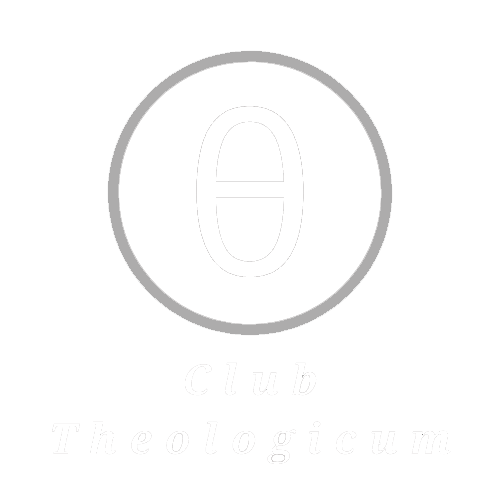

Lascia un commento