Introduzione
Il libro di Osea, a dispetto della sua età, racchiude tematiche e concetti inaspettatamente molto attuali, tanto che si può affermare che – sotto diversi aspetti – si tratta di uno dei libri – cerniera che avvicina le due Alleanze.
Siamo intorno all’VIII secolo a.C: contemporaneo di Amos, Osea iniziò l’attività profetica negli ultimi anni di Geroboamo. L’anno 753 a. C. segna l’inizio della crisi, dopo un periodo di prosperità: si susseguono lotte feroci per la conquista del potere. La guerra civile portò alla divisione del Nord in due territori (che Osea chiama «Efraim» e «Israele»): sotto l’aspetto religioso, il culto ufficiale, ormai puramente esteriore, si affianca al culto di Baal, che prevede anche pratiche immorali, come la prostituzione sacra.
Il messaggio è in parte coincidente con quello di Amos, sia nella denuncia dell’ingiustizia e della corruzione sia nella contestazione del culto superficiale e superstizioso. Al contrario di Amos, in quest’opera, la successione di castighi risultano come un processo al fine di indurre alla conversione. La grande novità che mostra Osea come un precursore del Nuovo Testamento è proprio far precedere il perdono alla conversione, moto che caratterizza diversi episodi evangelici[1].
Osea è chiamato il profeta dell’amore perché al centro del suo libro c’è l’amore: quello di Dio, così tenace da ricercare ostinatamente di far tornare a sé il proprio popolo. È il popolo ad essersi allontanato e “prostituito”. È nell’interesse del popolo tornare a Dio. Eppure, è Dio il primo a domandarsi come fare per farlo tornare. Quasi a suggerirci che, nonostante appaia il contrario, niente è più forte, della dolce ostinazione della tenerezza.
Dio e Israele: nuzialità, paternità e misericordia
Tra i temi principali, c’è sicuramente l’infedeltà di Israele: è Osea il primo in assoluto ad usare esplicitamente l’immagine del matrimonio per indicare l’alleanza tra Dio e il suo popolo (tale metafora sarà poi ripresa da Isaia, Geremia ed Ezechiele). Dopo aspri richiami, si conclude però con un messaggio di tenerezza che il Signore rivolge al suo popolo e si riflette su ogni credente. Il rapporto con Dio si macchia d’infedeltà, l’adulterio[2] è quindi simbolo dell’idolatria del popolo nei confronti di Baal.
Un secondo tema, che diventa ponte tra Antica e Nuova Alleanza è poi quello della paternità. Ripreso in seguito da Geremia (3,4-5.19), trova la propria piena applicazione del Nuovo Testamento, dalla parabola del Padre Misericordioso (Lc 15,11-32), alla preghiera del Pater (Mt 6,9-13 / Lc 11,2-4).
Il terzo tema, forse in assoluto il più ripreso e il motivo principale per cui, lo scorso anno, questo libro è tornato particolarmente in auge, è la richiesta che la misericordia prevalga sul sacrificio (Os 6,6): risuona da Samuele (1Sam 15, 22) ed è citato nel vangelo di Matteo (Mt 9,13 e 12,27).
Struttura
Il testo, pur essendo piuttosto composito nella sua realizzazione, può essere suddiviso in tre grandi sezioni.
Nella prima (capitoli 1-3) troviamo un racconto autobiografico, un racconto biografico, un poema sullo sposo e sulla sposa e diversi oracoli di salvezza.
La seconda (capitoli 4-11) contiene invece degli oracoli sulla denuncia del culto e della politica.
La terza sezione (capitoli 12-14), infine, dopo una lunga requisitoria, si conclude con un oracolo di salvezza, che fa riferimento all’alleanza.
Prima parte: amore e deserto
Amore e deserto sono gli ingredienti fondamentali che costituiscono i primi due capitoli del libro di Osea.
Il primo capitolo si apre con l’esplicita richiesta, al profeta, di prendere in moglie una prostituta, Gomer, ed avere dei figli con lei. Fortemente significativi (nomen omen) sono i nomi che saranno dati ad essi. Il primo figlio si chiama Izreèl: evoca una memoria storica di dolore: il campo di Izreèl (regione montuosa della Giudea) è campo di morte, per Jezebel (2 Re, 36), di cui il Signore vuole punire il re Jehu; ma il significato del nome è anche positivo (“Dio semina”): il destino di morte e distruzione è quindi solo apparente, come è apparente la morte del seme che, nascosto sotto terra, si prepara a nuova vita. Anche la seconda figlia prende un nome che è tutto fuorché beneaugurante: «chiamala Lo-Ruama (cioè “non-Amata”), perché io non avrò più compassione della casa d’Israele in modo da perdonarla» (Os 1,6). Segue un terzo figlio, il cui destino non è migliore, anzi: il suo nome indica il rifiuto più totale: «chiamalo Lo-Ammi (non-mio popolo), perché voi non siete mio popolo e io non sono per voi».
La prima, inevitabile, riflessione è il ruolo del nome, nella nostra vita. Un nome ci è apposto alla nascita, nomignoli e vezzeggiativi si susseguiranno, nel tempo. Purtroppo, talvolta, capita anche che affibbiamo nomi volgari, per offendere le persone. È il procedimento con il quale cerchiamo di togliere dignità dal di dentro, svuotando di significato l’essere umano. Del resto, tanto è importante la comunicazione attraverso la Parola, che, nella Genesi, la Parola di Dio è creatrice[3].
Secondariamente, lo sguardo si sposta sul rifiuto e la sua drammaticità. Rifiutato dal popolo, anche Dio decide di fare un passo, rigettando l’alleanza sancita sul Sinai[4]. Questa pagina risulta attualissima. È infatti il rifiuto il nucleo centrale della sofferenza umana, in ogni tempo ed in ogni luogo, ma pare particolarmente evidente in quest’epoca. Il rifiuto di un figlio e nella sua promessa di futuro si esplica nel dramma dell’aborto. Il rifiuto della malattia e la sua possibilità di vivere la Bellezza, nonostante la sofferenza, porta al dramma dell’eutanasia. Il rifiuto di una progettualità condivisa, conduce al divorzio e alla rinuncia alla stabilità dei rapporti, con tutto il dolore che ne consegue, come fallimento personale e come strascico sui figli. Eppure, subito dopo queste parole così gravi di rifiuto totale, arriva, inaspettata, la speranza:
Invece che dir loro, come si diceva: «Voi non siete mio popolo», sarà loro detto «Siete figli del Dio Vivente» (Os 1,10)
“Il castigo di Dio non è mai l’ultima parola; esso è sempre per la vita, in vista di un riscatto, non è per la morte, ma per la vita”[5]. Dopo aver detto di aver rigettato Israele, dirottando la propria eredità verso Giuda, precisa invece di rivendicare, invece, il proprio popolo, tutto intero, per sé. Dio rimane fedele. A se stesso ed alla propria promessa. Nonostante tutto, nonostante le infedeltà, la promessa si realizzerà. Gomer (immagine del popolo d’Israele e – per noi – immagine della Chiesa, ma anche di ogni singolo credente) è messa di fronte alle proprie colpe, mancanze e superficialità. Il profeta (qui, immagine di Dio stesso) la ama, malgrado le sue prostituzioni.
Ecco perché, nonostante le infedeltà è Lui stesso a fare il primo passo, ad impegnarsi per riconquistarla, affinché ella comprenda quanto sia amata e ritorni, quindi, da lui. Inizialmente, di fronte all’allontanamento del popolo, che segue gli idoli cananei, Dio, vorrebbe abbandonarlo al proprio destino. Dio, però non riesce a staccarsi. Se l’amore dello sposo per la sposa, nel Cantico dei Cantici, è descritto come forte quanto la morte, quello di Dio per il proprio popolo, va oltre: è più forte persino della morte. Perché tale è – in sostanza – la volontà di cancellare completamente la presenza di Dio nella mia vita. “L’amore non è questione di meriti, mai” scrive Giorgio Ponte nel suo Giairo[6]. È questa la conferma che troviamo nel libro di Osea. Come nella parabola del Padre Misericordioso[7] , anche qui c’è di mezzo un ritorno, che può avvenire solo dopo aver sperimentato la solitudine e l’abbandono. Il peccato inizialmente risulta piacevole, appagante: porta con sé il gusto adolescenziale del brivido della trasgressione. Il figlio minore ritorna in sé, solo dopo aver assaporato l’amarezza della solitudine, i morsi della fame e la mancanza di dignità, arrivata fino al punto da fargli desiderare delle carrube che i porci (che portava al pascolo) mangiavano.
«Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore» (Osea 2, 16)
È necessario attraversare un deserto, per trovare la vera vita. Fu così nell’Esodo israelitico[8] , fu così per Gomer e, spesso e volentieri, è così anche per noi. Anche noi abbiamo bisogno del deserto, per riuscire ad avvertire pienamente ciò che manca. Il deserto rappresenta una situazione – limite in cui ci veniamo a trovare, per cui, spogliati di tutto, dopo aver fatto terra bruciata di ogni superfluo, è possibile affrontare con realismo e senza sotterfugi, i problemi della relazione in crisi. Solo così è possibile ricordare gli albori di tutta la storia e fare chiarezza nel nostro intimo[9].
Il deserto mostra la pedagogia di Dio all’opera, che esige la fatica della conversione, per riportare alla memoria la freschezza del primo incontro, quello che aveva fatto battere il cuore. Conduce l’amata verso di sé, lontano dalla folla, da qualunque possibile distrazione, per poterle parlare, sotto voce, come fanno gli innamorati: cosicché lei ascolti realmente, con rinnovato interesse e con viva attenzione. Cosicché lui possa finalmente comprendere cos’alberghi nel cuore di lei e cosa l’abbia fatta allontanare.
«Mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone» (Os 2,18): il secondo viaggio di nozze, con annesso chiarimento, porta i propri frutti. L’amore era avvelenato dall’incomprensione. Convinta di essere schiava, cercava la libertà tra gli amanti e i loro costosi doni (Os 2,14), perché non aveva capito che il vincolo d’Osea era d’amore e non di schiavitù. Come il servitore della parabola dei talenti[10] che, reso libero e padrone dei propri beni dal datore dei beni, ha continuato a vivere da schiavo e, malfidente, ha preferito sotterrare il proprio talento, piuttosto che investirlo nel Bene.
«Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata; e a Non-mio-popolo dirò: Popolo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio» (Os 2,25)
In questo finale del capitolo secondo, “mio” è aggettivo possessivo che ritorna sulla bocca, quasi cadenzato ritornello di un cantico del ritrovato amor perduto. Lungi dall’essere brama, è – piuttosto – garanzia di custodia. “Sei mio, perché sei parte del mio cuore: mi prendo cura di te, anche al di là della gratitudine che mi dimostri, vorrei la tua felicità ed il tuo vero bene e, per questo, vorrei difenderti da tutto, persino da te stesso, se solo fosse possibile!”.
Osea, nella parte narrativa del terzo capitolo, decide quindi di riprendere con sé, nonostante tutto, la sposa infedele e i figli avuti da lei. Così è la storia di tutta l’umanità, una storia fatta di patti stretti, rotti e ricomposti nuovamente, nell’alternarsi delle inevitabili infedeltà del nostro incostante amore.
«Non esiste matrimonio senza deserto, non esiste amore senza solitudine, non esiste incontro senza separazione. È la grande e faticosa storia di ogni esperienza d’amore, al di là del matrimonio, perché ogni amore è improntato sullo stesso modello»[11]: Dio è relazione e nello sperimentare la relazione viviamo, sempre, pur se in modo approssimativo e frammentario, un riflesso di quello che è l’amore di Dio, perché è qui che risiede il nostro essere “a sua immagine”, vale a dire nella possibilità di amare in modo gratuito.
Seconda parte: “Come chi solleva un bimbo alla guancia”
Nel quarto capitolo del libro, Osea procede alla disamina delle colpe “reali” e storiche, al di là dell’immagine sponsale, discernendo con attenzione le colpe dell’intero popolo, da quelle dei sacerdoti. Nell’analizzare le colpe del popolo, l’accusa è totale, in quanto mancanza di fronte ad un amore (quello di Dio), che è totalizzante (Os 4,1-3). La descrizione che fa il profeta è di disastro totale: perfino la creazione ne soffre, a sottolineare che «il male non danneggia solo chi lo commette, ma diventa fermento di morte per tutti»[12] Si tratta di un aspetto fondamentale, che è bello sottolineare a scanso di equivoci: non è vero che sia trascurabile ciò che riguarda soltanto me. Perché, in quanto membri del corpo di Cristo, ogni nostro peccato o sofferenza tocca il corpo di Cristo e tutto il corpo ne soffre; al contempo, naturalmente, ogni mia adesione al bene contribuisce – poco o tanto, ma sempre – all’edificazione del “Cristo totale”.
Tuttavia, l’autore dell’opera trova la radice del peccato nella mancanza di conoscenza di Dio e quest’ultima è da ascrivere ai sacerdoti che, come casta, allontanano da Dio chi non ha gli strumenti per conoscerLo, senza il loro aiuto. Da ciò, prende l’avvio l’accusa ai sacerdoti.
«Contro di te, sacerdote, muovo l’accusa» (Os 4,4b): questo “tu” riguarda ciascuno di noi, dal momento che, in forza del Battesimo, siamo chiamati ad essere re, sacerdoti e profeti, in quanto parte del Corpo di Cristo, che ha questi incarichi e ci ha lasciato il testimone.
L’invito è, quindi, a diventare protagonisti della nostra personale storia di fede, se necessario, anche qualora i sacerdoti ordinati mostrassero la propria inadeguatezza. La conoscenza, nella Bibbia, non è mai puramente intellettuale, bensì esperienza diretta, a cui siamo chiamati.
Mentre Israele si allontana da Dio, Questi, però, non si allontana da Israele e “si fa trovare da chi non Lo cerca” [13]. Il popolo, convinto dai capi, s’illude di ritrovare Dio tramite il ritorno ai riti, ma non è possibile che ciò avvenga se quei riti non sono manifestazione d’amore. Com’è possibile “acquistare” i favori di Dio, moltiplicando i doni per Lui, che già tutto possiede e nulla Gli manca?
Qui arriviamo al verso forse più famoso di tutto il libro di Osea (6,6): «Misericordia voglio, non sacrifici; la conoscenza di Dio, più degli olocausti». L’invito è a riempire di senso il rito, espandendolo nella concretezza della vita, affinché diventi essa stessa liturgia gradita a Dio.
Abbiamo ribaltato i rapporti di forza, rendendo il divino a nostra immagine e somiglianza, ma non curandoci di assomigliarGli. In quest’esortazione, Osea riprende il profeta Amos che invita a cercare la giustizia, invece di moltiplicare i riti con cui rendere un onore solo esteriore a Dio[14].
Nell’ottavo capitolo, troviamo l’origine di un detto popolare famosissimo, di cui, però, probabilmente, tanti dimenticano l’origine biblica:
«Hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta» (Os 8,7)
Sia il Nord che il Sud dimostrano desiderio di autonomia da Dio, nell’illusione di poter “bastare a se stessi”: mentre il primo si dà all’idolatria, il secondo “moltiplica le fortezze” (Os 8,14), manifestando fiducia nella propria forza militare. Se ci pensiamo, questa è una tentazione molto viva nella nostra vita: la volontà di relegare Dio alla domenica, per la Messa, senza però accettare che la Parola interroghi la vita in profondità e nella quotidianità ci accompagna. Quante fortezze costruiamo, per non evitare di comprometterci “troppo” con la parola di Dio?[15] Quanto spesso, anche noi reagiamo in questo modo risentito, almeno nel pensiero?
Proprio la mancanza di un culto autentico lega il popolo a un dio che non libera. È la libertà il sigillo di garanzia. Dio mette in guardia dal peccato, ma non impedisce di compierlo. Di fronte al figlio minore che lo dichiara morto anzitempo, chiedendogli l’eredità in anticipo, il Padre acconsente alla richiesta, pur con la tristezza nel cuore e lascia che si allontani; non lo rincorre, né gli impedisce di sbagliare, pur attendendo con ansia il ritorno, tanto che gli corre incontro, quando quello è ancora lontano e ciò è possibile solo perché il Padre non aspettava altro e continuava a guardare dalla finestra, in attesa del suo ritorno[16]. A Dio sta a cuore il nostro libero arbitrio, come mostra la Sacra Scrittura, motivo per il quale risulta arduo pensare che possa accontentarsi dell’arbitrio servile, di cui parla Lutero. Senza libertà, non è possibile neanche l’accoglienza (autentica) del progetto di Dio su di noi.
Il decimo capitolo mostra l’apice dell’allontanamento di Dio.
«Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore: ero come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare» (10,4): Dio enumera il bene compiuto verso Israele, nella metafora di un padre premuroso. La forza paterna non viene meno di fronte al figlio piccolo, ma si adatta a lui, diventando tenerezza e sostegno alla sua fragilità.
«Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione» (11,8) dice Dio: la tenerezza vince il cuore di Dio. Pur lasciando la libertà, Dio non può non vedere l’angoscia e lo struggimento che colgono chi si allontana. Il profeta Osea, portavoce della Parola di Dio, precorre il Nuovo testamento, mettendo a nudo un Dio i cui “visceri” sono lacerati, di fronte al perseverare nel Male dei propri figli. Come un adolescente, ribelle, allontanandosi da casa, cerca la propria libertà e vuole sperimentarsi in qualcosa di nuovo: spesso, però, non ottiene che dolore e frustrazione. Nel libro di Osea, Dio si mostra in tutta la propria fragilità: la fragilità dell’uomo sembra quasi mettere in difficoltà Dio, che, pur rimanendo a distanza, non può fare a meno di guardare i tentativi di autonomia del proprio popolo, con la tenerezza di un Padre. Di più. Come una madre, di fronte al figlio che ha preso la via della perdizione: vorrebbe intervenire, ma spesso non le è possibile. Vede il figlio smarrirsi e l’unica opzione che le rimane è perdurare anch’essa nell’amore per lui, speranzosa che la propria fedeltà nell’amore possa condurre il figlio a comprendere i propri errori.
Terza parte: ricerca d’autonomia
Nel dodicesimo capitolo del testo, vediamo che la ribellione non è solo frutto di un peccato, ma è l’inseguimento consapevole di una fantomatica “autonomia”. Ciò è evidenziato anche ripercorrendo la storia di Giacobbe[17], soprattutto secondo questo punto di vista: ne sono infatti notati soprattutto i motivi per cui non dovrebbe essere un modello, cioè la tendenza ad ingannare, pur di ottenere quanto persegue (Os 12,4-7). Si parla, in modo esplicito, dell’inganno, tramite bilance false (Os 12,8): la gravità di questa colpa risiede proprio nell’inganno, cioè nel “perseverare” nel peccato, nel non riuscire ad ammettere di avere commesso peccato.
Il mix letale di idolatria, ingratitudine e la collezione di una serie di scelte politiche errate (nel tentativo di essere autonomo) sta conducendo Israele verso la decadenza. Allora l’unica arma in mano a Dio è ricordargli l’Alleanza (Os 12, 10-15).
Shemà, Israel! Ricorda, Israele. È più di una liturgia, è un far memoria, del cuore e della mente insieme, che unisce il passato al presente, per poterlo proiettare nel futuro, con energia rinnovata. ecco, allora che, proprio nel momento dell’allontanamento, si riaffaccia il solenne ricordo dell’alleanza sancita nel deserto (Es 20,2). Il ritorno al vero Dio e la purificazione del cuore avviene davvero solo grazie al ricordo del bene ricevuto in modo gratuito.
«Dio ama l’umanità non perché essa è buona, ma perché Lui è buono»[18]
È questa la grazia: il bene, che si riceve gratis, in modo gratuito e immeritato (non unicamente nel senso che non è meritato – o, meglio, “meritabile” – bensì, più in profondità, perché ricevuto al-di-là dei meriti, oltre essi). Se sperassimo di ricevere amore in modo proporzionale alle nostre forze, avremmo sicuramente mal riposto le nostre speranze. La grazia che ci ricopre è ricevere in modo sproporzionato occasione d’amare ed essere amati, al di là dei nostri meriti e sulla base del progetto di Dio su di noi.
Nel tredicesimo capitolo, troviamo la condanna del culto di Baal, che, prevedeva, tra gli altri, la prostituzione sacra: per questo motivo, d’ora innanzi, la parola prostituzione, nella Bibbia, sarà spesso accostata all’idolatria, diventandone quasi sinonimo, nell’immagine del popolo di Dio come sposa del Signore. Rispetto a questi versi, tendiamo a sentircene, a torto, lontani, come se non potessero riguardarci perché non sappiamo, forse, neppure chi sia Baal e, di conseguenza, non lo abbiamo mai seguito. In realtà, il rischio di idolatria è tremendamente quotidiano e noi siamo chiamati a distruggere la nostra, personale idea di Dio, per rispolverare e riscoprire chi sia veramente, per non incorrere, anche noi, nell’idolatria di un Dio che non corrisponde al vero Dio. È così in tutti i rapporti.
Ed è vero soprattutto in una psicologia al femminile: la tendenza è crearsi un modello, idealizzare le persone, fino a sostituirle alla loro realtà. È necessario distruggere la nostra idea sulle persone, per evitare di amare un ideale inesistente, al posto della realtà. Spesso, proprio questo è il vero motivo per cui le persone ci deludono. Non le conosciamo veramente, ci facciamo un’idea su di loro, a partire da pochi elementi e, rifiutando di approfondire la realtà, creiamo enormi castelli in aria, dal contenuto fantastico. Illudendoci, però, che corrispondano a realtà, rischiando così di creare un mondo utopico, esistente solo dentro alla nostra testa.
«Eppure io sono il Signore tuo Dio
fin dal paese d’Egitto,
non devi conoscere altro Dio fuori di me,
non c’è salvatore fuori di me.
Io ti ho protetto nel deserto,
in quell’arida terra.
Nel loro pascolo si sono saziati,
si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito,
per questo mi hanno dimenticato».
(Os 13, 4-6)
Anche noi, spesso, ci comportiamo come il popolo d’Israele: ci ricordiamo di Dio, nelle difficoltà: per il resto del tempo, preferiamo “vivere come se non esistesse”. Del resto, è illusorio pensare la fede come la soluzione ai nostri problemi: la realtà ci dimostra che non è così. Credere non ci evita la sofferenza, la malattia o il dolore, pur offrendoci una prospettiva di speranza con cui guardare a tutto ciò.
Nei versi seguenti (8-9), arriva ad una metafora feroce, dicendo che sbranerà il proprio popolo. Eppure, «quando YHWH combatte contro il suo popolo, combatte contro se stesso: quando fa male al suo popolo, fa male a se stesso; quando porta il suo popolo verso la libertà facendolo passare attraverso sofferenze enormi, sottopone se stesso a queste sofferenze enormi. […] Non è vero che il modello di Dio rappresentato nella Bibbia sia un modello di Dio troppo alto: è troppo umano. […] Il Dio che tocca la nostra storia, che passa le nostre stesse peripezie, i nostri stessi dubbi, , le nostre stesse incertezze, le nostre stesse paure, è un Dio che ci disorienta. Dio dice: “Non ti preoccupare, ci sono anch’io” ma a noi questo non basta»[19]. In altre parole: il Dio difficile da accettare ha il volto inerme di chi si lascia vincere dalla tenerezza e non anestetizza i sentimenti nel calcolo utilitaristico. Si fa nostro compagno nella sofferenza (come, del resto, Cristo sulla Croce) e ci sprona, innanzitutto, affinché noi ci facciamo compagni gli uni gli altri delle altrui sofferenze. Non ci abbandona mai, perché è il sempre-presente[20] (“Io sono” cfr. Es 3,14).
«Ognuno esiste, nella relazione, perché appartiene all’altro» (A. Chieregatti): è così nei rapporti tra le persone, più evidente, forse, nell’innamoramento, in cui ciascuno di noi “prende luce” dallo sguardo amante che si riversa di lui. Così è, a maggior ragione, nel rapporto con Dio, ognuno acquista significato proprio nell’amore che lo riveste.
Infatti, come il figlio citato da Osea (13,13), anche noi, a volte, rifiutiamo la vita, ci spaventiamo di fronte alle difficoltà, fino a desiderare, talvolta, in un impeto di rabbia e di disperazione “di non essere mai nati”. La vera domanda che sottende la sensazione di non voler vivere non è la vita in sé, bensì la domanda radicale: «Ne vale la pena?». Perché l’uomo è capace di imprese grandiose, a fronte di un motivo che sappia scuoterlo e metterlo in marcia. Fino al paradosso che, spesso, trovano più ragioni per vivere proprio le persone che, a logica, dovrebbero fare più fatica a trovarne
«Dov’è, o morte, la tua peste? Dov’è, o inferi, il vostro sterminio?» (Os 13,14) sono i versi che San Paolo riprende (1Cor 15,55), trasformandoli in un saluto alla morte, ormai sconfitta dal trionfo della Resurrezione di Cristo, che nella Sequenza Pasquale è reso metaforicamente con l’efficace immagine di un duello tra vita e morte: Mors et vita duello conflixére mirando: dux vitae mortuus regnat vivus (morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello: il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, regna).
Al primo verso del quattordicesimo capitolo, la situazione appare tragica, tanto che la domanda è se sia il caso di trasmettere ancora la vita. Ciò che segue risulta infatti un’aggiunta successiva, rispetto al resto e costituisce una sorta di liturgia penitenziale di un reale ritorno (dopo un primo, solo superficiale, al capitolo 6), stavolta con un pentimento sincero, di Israele all’Unico che può davvero salvare e proteggere.
“Torna” è il leit-motiv dell’intero capitolo conclusivo e rappresenta – insieme – augurio, auspicio ed esortazione. Come il figlio prodigo che, pur tornando a casa, è consapevole delle proprie colpe e dei propri non – meriti, non è ancora fiducioso nel perdono. Eppure, “spera contro ogni speranza”[21], perché la lontananza gli aveva svelato la bontà del Padre.
«Ritorneranno a sedersi alla mia ombra» (14,8) sancisce, nel finale, il profeta. Sedersi “all’ombra di Dio” è avere la certezza di Qualcuno al proprio fianco, pronto proteggerti. Ѐ il suggello del patto ricomposto, dell’alleanza riallacciata, tra Dio e il suo popolo, tra Dio e ciascuno di noi.
Non illudiamoci che questo segni la fine. La nostra natura umana, soggetta al peccato, non ci consente quella fedeltà che vorremmo. Per cui, soltanto nodo dopo nodo, l’alleanza si ricucirà nuovamente, fino alla comunione totale, in Dio, al di là del velo della morte.
*** Maddalena Negri ***
[1] È così, ad esempio per l’episodio dell’incontro con la Samaritana (Gv 4,5-42) o dell’adultera (Gv 8,1-11).
[2] Il paragone è, del resto, favorito proprio dalla prostituzione cultuale, praticata nei templi di Baal.
[3] Cfr. Gen 1-2
[4] Dt 26,16-18
[5] A.M.CANOPI, Là parlerò al suo cuore, lectio divina sul libro di Osea. Milano, Paoline, 2005
[6] G. PONTE, Giairo, Youcanprint, 2017
[7] Lc 15
[8] Deut 5
[9] «Vi sono tante forme di deserto. Vi è il deserto della povertà, il deserto della fame e della sete, vi è il deserto dell’abbandono, della solitudine, dell’amore distrutto. Vi è il deserto dell’oscurità di Dio, dello svuotamento delle anime senza più coscienza della dignità e del cammino dell’uomo. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi. Perciò i tesori della terra non sono più al servizio dell’edificazione del giardino di Dio, nel quale tutti possano vivere, ma sono asserviti alle potenze dello sfruttamento e della distruzione. La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza»: questa la lirica descrizione che Benedetto XVI offre del deserto (Omelia di insediamento, 24 aprile 2005)
[10] Mt 25, 14-30
[11] A. CHIEREGATTI, Osea. Lettura spirituale, EDB, 2012, p.34
[12] A.M. CANOPI, op. cit., p. 37
[13] Is 65,1
[14] “Io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni; anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti: il suono delle tue arpe non posso sentirlo! Piuttosto scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne.” (Am 5, 21-24).
[15] Bene si è fatto interprete di tale pensiero il don Rodrigo di manzoniana memoria, che borbottava, all’intromissione di fra Cristoforo nei suoi loschi piani:
«Lei mi parlerà della mia coscienza, quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode ne son io, e io solo; e che chiunque ardisce entrare a parte con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che l’offende».
[16] cfr. Lc 15, 11-32
[17] Gen 25-35
[18] A.CHIEREGATTI, op.cit., p. 119
[19] A.CHIEREGATTI, op.cit., p.127
[20] Io-Sono, cfr. Es 3,14
[21] Rm 4,18, in cui, però, fa riferimento ad Abramo
Fonte immagine: media.front
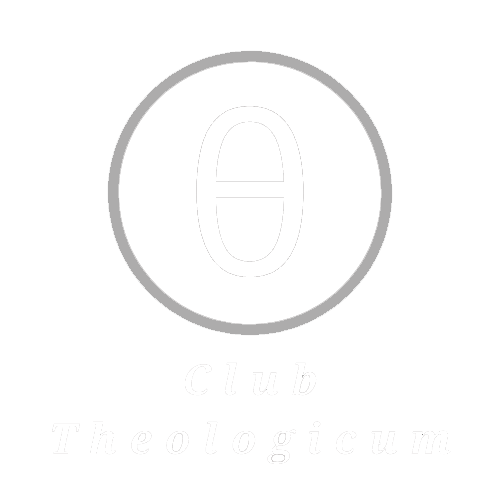

Lascia un commento