Come il precedente concilio ecumenico, il Terzo Concilio Lateranense seguì la fine di un lungo periodo di scisma che in questo caso era iniziato con la contestata elezione di papa Alessandro III nel 1159, alla quale era seguita l’elezione di una serie di tre antipapi sostenuti dall’imperatore Federico Barbarossa, e fu effettivamente conclusa con l’accordo tra questi e il papa stipulato a Venezia nel 1177. Una lista superstite dei partecipanti al Concilio, la prima del genere, registra la presenza di circa 300 vescovi e numerosi abati. Tra questi, oltre a prelati italiani, ce n’erano di francesi, tedeschi, inglesi, irlandesi, scozzesi, dalmati, spagnoli, danesi, ungheresi e persino alcuni provenienti dai regni crociati. Erano presenti inoltre anche inviati di molti sovrani cristiani.
Le sessioni del Concilio si tennero il 5, 14 e 19 marzo del 1179, e furono promulgati 27 canoni. Il sinodo, sia per le sue circostanze che per i suoi risultati, occupa un posto importante nella storia del diritto canonico: fu il primo concilio ecumenico nel periodo dello ius novum, e fu presieduto dal primo dei grandi papi canonisti, Alessandro III, al secolo Rolando Bandinelli. I canoni del Concilio furono ampiamente diffusi e furono prontamente ripresi nelle nuove raccolte di decretali, da cui passarono nella Compilatio prima e infine nel diritto canonico ufficiale nelle Decretales gregoriane del 1234.
Fra i canoni è particolarmente noto il primo: esso stabilisce che per scongiurare il pericolo di nuovi scismi il pontefice sia eletto da almeno due terzi dei cardinali presenti al conclave. Questa norma poi divenne stabile nelle elezioni dei Sommi Pontefici ed entrò in tutti i documenti posteriori compilati al riguardo, tanto da essere ancora contemplata nell’attuale Codice di Diritto Canonico.
Il secondo canone sancisce la nullità delle ordinazioni fatte dagli antipapi Vittore IV, Pasquale III e Callisto III. Il terzo determina le qualità richieste dai ministri del culto: il vescovo deve avere compiuto 30 anni, non avere una moglie ed aver tenuto una condotta di vita senza macchia; i membri della curia vescovile ed i curati beneficiati debbono avere almeno 25 anni ed aver condotto una vita di specchiata onestà: gli elettori che abbiano scelto un candidato indegno sono privati del loro diritto di suffragio, che passa al vescovo, oppure dal vescovo al metropolita. Nel quarto canone sono condannati gli abusi commessi dai prelati nel compiere le visite pastorali. Il quinto canone afferma la necessità del titolo per l’ordinazione. Il vescovo che abbia ordinato un diacono o un prete privo di mezzi per mantenersi è tenuto a provvedere ai bisogni di costui.
Il sesto canone detta alcune regole di procedura: nessuno può essere condannato senza previa ammonizione; l’appello deve essere perseguito nei termini stabiliti dal giudice; in mancanza di questi l’appellante decade dal proprio diritto ed è condannato alle spese. Il settimo canone colpisce la simonia. L’ottavo tratta del conferimento dei benefici: questi non possono essere né promessi né conferiti prima della vacanza, ma debbono essere conferiti entro i sei mesi dalla loro vacanza; in mancanza di ciò il conferimento passa dal vescovo al capitolo e, in mancanza di quest’ultimo, al metropolita. Il nono canone condanna le usurpazioni dei religiosi, in particolare dei templari e degli ospedalieri, soprattutto in materia di decime. Il decimo cannone vieta ai monaci cistercensi di infrangere il loro voto di povertà e di immischiarsi nella organizzazione feudale. L’undicesimo canone colpisce la condotta illecita da parte del clero, prevedendo la deposizione per gli ordinati dediti ai rapporti omoerotici e l’esautorazione di quei chierici che si intrattengano in maniera illecita nei monasteri femminili. Il dodicesimo canone vieta ai chierici di impegnarsi in talune professioni, come quella di avvocato (a meno che non la esercitino per loro stessi, di una chiesa o dei poveri). Il tredicesimo vieta l’accumulo dei benefici. Il quattordicesimo canone vieta ai laici di disporre dei beni delle chiese. Il quindicesimo canone limita la capacità testamentaria degli ecclesiastici, i quali non possono includere nei propri lasciti i proventi acquisiti in ragione della loro carica. Il sedicesimo canone stabilisce che le deliberazioni delle comunità ecclesiastiche debbano essere prese assecondando il parere della maggioranza dei loro membri. Il diciassettesimo stabilisce che ogni chiesa deve vere un unico rettore.
Il diciottesimo canone dispone che ogni cattedrale debba avere una scuole ove i bisognosi possano essere ammessi e stabilisce alcune norme attorno all’insegnamento. Il diciannovesimo stabilisce che laici non possono esigere canoni dalle chiese, né usurpare la loro giurisdizione. Il ventesimo canone ribadisce il divieto dei tornei, in quanto rappresentano un pericolo per l’anima e per la vita corporale. Il ventunesimo sancisce la Tregua di Dio. Il ventiduesimo stabilisce alcune norme per la sicurezza degli ecclesiastici, dei pellegrini, dei monaci e dei mercanti. Il ventitreesimo si occupa della salute spirituale dei lebbrosi, stabilendo che questi devono avere una chiesa propria ed un sacerdote che si occupi della stessa in modo esclusivo. Il ventiquattresimo sancisce la scomunica con chi collabori con i saraceni. Il venticinquesimo canone stabilisce delle sanzioni contro gli usurai. Il ventiseiesimo stabilisce alcune sanzioni contro gli ebrei e i musulmani. Infine, il ventisettesimo canone stabilisce sanzioni contro i catari, i briganti e i predoni.
Adriano Virgili
Alcuni riferimenti bibliografici:
Pietro Palazzini (a cura di), Dizionario dei concili, Roma, Città Nuova, 1963-1968, VI Voll.
Giuseppe Alberigo (a cura di), Decisioni dei concili ecumenici, Torino, UTET, 1978
Pierre-Thomas Camelot, Paul Christophe, Francis Frost, I concili ecumenici, Brescia, Queriniana, 2001
Klaus Schatz, Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali, Bologna, EDB, 2012
Marina Benedetti (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età medievale (secoli VIII-XV), Roma, Carocci, 2015
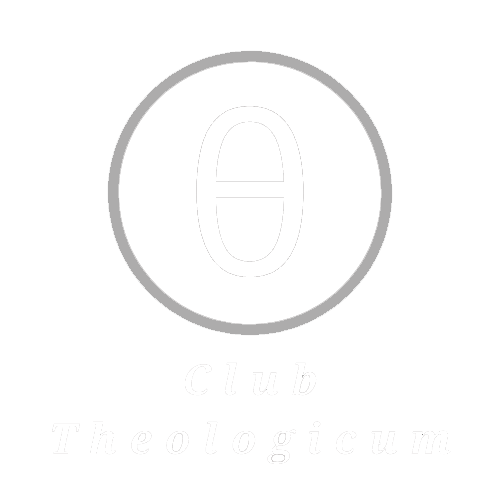

Credo che la disposizione secondo cui i lebbrosi dovessero avere una chiesa a parte fosse perché allora si credeva ancora che la malattia fosse contagiosa per contatto. Se così fosse si potrebbe utilizzare questa informazione per contraddire la tesi di alcuni secondo cui – durante la pandemia – dovessero accogliere in chiesa proprio tutti, tra poco anche i positivi al Covid, perché Gesù accoglie tutti, andava in mezzo ai lebbrosi e si è sempre fatto così… o mi sbaglio? Come funziona?
"Mi piace"Piace a 1 persona
Esatto, oggi sappiamo che la lebbra si tramette solo nella fase iniziale della malattia, quando i segni della stessa sono ancora praticamente invisibili, all’epoca questo non si sapeva e si credeva che la lebbra si trasmettesse per contatto fisico con i malati. Da qui l’usanza, sin dall’antichità, di isolare i lebbrosi in comunità specifiche.
"Mi piace""Mi piace"