Basilea
A Siena il 19 febbraio 1423 Martino V annunciò la convocazione di un Concilio per il 1 febbraio 1431 a Basilea. A seguito dello Scisma d’Occidente (1378-1417), dei cardinali avevano convocato un concilio a Pisa nel 1409, in modo indipendente dal papa. Questo conciliarismo pratico aveva trovato espressione teorica nel Concilio di Costanza (1414-18), che aveva dichiarava che un concilio generale era la massima autorità della Chiesa. Il partito conciliarista emerse in modo particolare proprio durante il Concilio di Basilea, il quale può essere diviso in due periodi. Gli eventi del Concilio di Basilea si dividono in due periodi: quello del concilio vero e proprio (1431-1437) e quello del cosiddetto conciliabulum (1437-1449).
Il concilio fu inaugurato il 23 luglio 1431, ma quando il suo presidente, il cardinale Giuliano Cesarini, arrivò il 9 settembre trovò pochissime persone presenti. Il 18 dicembre, a causa della scarsa partecipazione, del momento particolarmente complicato che l’Europa stava vivendo e della prospettiva di un concilio con i greci in Italia, Papa Eugenio IV, che nel frattempo era succeduto a Martino, prorogò l’assemblea con il progetto di riunirsi a Bologna dopo 18 mesi. I padri conciliari rifiutarono però di sciogliere l’assemblea e nella seconda sessione (15 febbraio 1432) adottarono il principio del Concilio di Costanza sulla superiorità conciliare, dando allo stesso un’interpretazione di tipo massimalista. Nuovi membri si unirono al sinodo, con l’idea di dare l’avvio ad una riforma atta a debellare il potere della curia di Roma. Alla fine di aprile erano presenti trentotto prelati e a Eugenio fu intimato di ritirare il suo scioglimento e di presentarsi al concilio di persona o per procura. Molti stati europei (con l’eccezione dell’Inghilterra, di Venezia, di Firenze e, dopo l’incoronazione di Sigismondo come imperatore il 31 maggio 1433, della Germania) appoggiarono il concilio. Eugenio cominciò a fare concessioni, ma non abbastanza rapidamente per il crescente senso di potere dei prelati presenti al sinodo. Con l’aumento dei suoi membri e il cedimento di Eugenio, il concilio divenne ancora più imperioso e minaccioso. Rifiutò di accettare i cinque presidenti nominati dal papa e impose il testo di una bolla che ne ritirava lo scioglimento. Eugenio, malato e quasi senza sostenitori, cercò di eludere la severità della formula proposta, ma alla fine promulgò il Dudum sacrum (15 dicembre 1433), nel quale leggiamo: “Decretiamo e dichiariamo che il suddetto concilio generale, fin dal suo inizio, è stato e viene portato avanti legittimamente… che deve essere portato avanti… per i suddetti fini [eresia, pace della Chiesa, riforma]”. Il 5 febbraio 1434 (16a sessione), sette cardinali, tre patriarchi (latini), 50 vescovi, 30 abati e 422 altri membri si dichiararono soddisfatti. Ma ricevettero i cinque presidenti papali solo dopo che questi ebbero prestato il giuramento conciliare con un’aggiunta speciale che affermava la supremazia del concilio (26 aprile 1434). A luglio arrivarono tre inviati greci con i quali si concordò di tenere un sinodo avente come fine la riunificazione della Chiesa (7 settembre) e per il quale furono indicate alcune possibili sedi. Eugenio, che all’epoca era esule a Firenze, acconsentì anche se in precedenza aveva preso accordi diversi con i greci. L’anno successivo, il 9 giugno 1435, il concilio vietò il pagamento delle rendite e rifiutò costantemente qualsiasi forma di compensazione per far fronte alle spese della corte papale. Il 14 aprile 1436 pubblicò un’indulgenza plenaria a favore del concilio greco-latino, ma temendo il prestigio che sarebbe derivato al papa se questo si fosse tenuto in Italia, insistette su Basilea o Avignone come sede dello sinodo, nonostante il ripetuto rifiuto dei greci e l’opposizione di Eugenio. L’atteggiamento intransigente del concilio su questo tema, insieme al suo feroce antagonismo al papato, indusse però molti a defilarsi. I cardinali si schierarono col papa e i governi europei, temendo un nuovo scisma, consigliarono più moderazione. Il concilio stesso si spaccò, perché mentre la maggioranza era favorevole a che il sinodo con i greci si tenesse Basilea o ad Avignone, una corposa minoranza era dell’idea che invece questo si tenesse in una delle città indicate nell’accordo siglato con i greci nel settembre del 1434. Il 7 maggio 1437, sia la maggioranza che la minoranza promulgarono simultaneamente un proprio decreto. La minoranza, con i delegati greci, sottopose il suo decreto a papa Eugenio, che si trovava a Bologna e che accettò di applicarlo. Subito dopo, Eugenio trasferì il Concilio di Basilea a Ferrara con la bolla Doctoris gentium del 18 settembre 1437. Questa bolla fu confermata il 30 dicembre, quando il Concilio di Basilea cessò legalmente di esistere. Il concilio, trasferito a Ferrara, durò fino al 1439.
Quando il concilio si riunì nel 1431, la Chiesa aveva indubbiamente bisogno di una riforma, l’attenzione. Le riforme imposte, sebbene poche, erano teoricamente positive. Alcune, tuttavia, erano impraticabili, almeno nella misura drastica in cui erano state previste. Il 13 luglio 1433 il concilio limitò le disposizioni papali in merito ai benefici; il 22 gennaio 1435 proibì il concubinato clericale e regolò la scomunica; il 9 giugno bandì ogni forma di pagamento, eccetto le nude spese amministrative, per il conferimento dei benefici, comprese le rendite al papa e, naturalmente, la simonia; il 24 marzo 1436 stabilì nuove norme per le elezioni papali e per la condotta, il numero e le qualità dei cardinali.
Un altro tema di cui si occupò il concilio fu l’estirpazione dell’eresia di John Wyclif (1330-1384), che era già stata condannata dal Concilio di Costanza, dove Hus era morto sul rogo, e un tentativo di mediazione con gli hussiti. Il partito hussita, infatti, non era venuto meno con la morte violenta del suo ispiratore e i suoi membri insistevano su quattro punti: la comunione sotto entrambe le specie, la punizione del peccato mortale da parte del potere secolare, la libertà di predicare senza restrizioni e la povertà evangelica per tutto il clero. Le trattative tra il concilio e gli hussiti iniziarono con l’Accordo di Eger (18 maggio 1432) che faceva delle Scritture, dei concili e dei dottori “il giudice più affidabile e imparziale”. Quindici delegati hussiti con un seguito di 300 persone si recarono a Basilea il 1 gennaio 1433. Gli inviati del consiglio si recarono a Praga con i delegati e tornarono a Basilea con tre hussiti in agosto. Successivamente, il Concilio di Basilea inviò i suoi stessi rappresentanti a Praga (18 novembre), Ratisbona (21 agosto 1434), Brunn (1 luglio 1435), Stuhlweissenburg (20 dicembre) e Iglau. Un accordo era stato raggiunto a Praga nel 1433, quando il concilio aveva concesso ai boemi l’uso del calice per la comunione. Le riunioni successive si occuparono dell’interpretazione dei quattro punti, in particolare della povertà. A Iglau (5 luglio 1436) i patti siglati furono promulgati solennemente, soprattutto perché l’imperatore Sigismondo ne garantiva l’adempimento. Nonostante le pressioni, gli hussiti non aderirono mai al Concilio di Basilea, così l’accordo decadde sotto Pio II nel 1458.
Con numeri molto ridotti, il concilio sfidò il decreto di Eugenio di trasferimento a Ferrara, dando inizio a quello che è poi passato alla storia come il conciliabulum. Inviò delle proprie navi a Costantinopoli per prelevare i delegati greci, ma questi preferirono salire sulle navi nel frattempo inviate dal papa. Il 24 gennaio 1438 dichiarò Eugenio sospeso e privato di ogni potere spirituale e temporale. Inviò forti delegazioni alle varie diete francesi e tedesche, ma resistette allo scioglimento in favore di un terzo concilio. Il 16 maggio 1439 dichiarò il principio della superiorità di un concilio sul papa una verità di fede cattolica e il 25 giugno depose Eugenio. Il 5 novembre elesse un antipapa, Felice V. In seguito scrisse lunghe risposte alle bolle papali, ma non approvò alcun canone. Nel febbraio del 1448 Federico d’Austria ritirò i suoi salvacondotti e i membri del concilio raggiunsero Felice a Losanna. Carlo VII di Francia patrocinò un accordo in base al quale il concilio si sarebbe sciolto. Felice si dimise. Il 19 aprile 1449, il concilio elesse il regnante Nicola V come successore di Felice e ribadì solennemente il principio della supremazia conciliare. Poi, il 25 aprile, decretò il proprio scioglimento.
Ferrara
Con le bolle Doctoris gentium del 18 settembre e Pridem ex iustis del 30 dicembre 1437, papa Eugenio IV aveva trasferito il concilio da Basilea a Ferrara. Lì si aprì l’8 gennaio 1438, sotto la presidenza del cardinale Albergati. Eugenio arrivò il 24 gennaio. Le prime sessioni si occuparono principalmente di affermare la validità canonica del concilio, nel dichiarare nulle le sanzioni votate a Basilea contro di esso e nell’imporre sanzioni agli oppositori. Per le votazioni, il concilio fu diviso in tre rami: prelati, abati e religiosi, dignitari ecclesiastici inferiori; perché una decisione conciliare fosse approvata era necessario il consenso dei due terzi di ciascun ramo.
I greci arrivarono a Venezia l’8 febbraio e a Ferrara tra il 4 e il 7 marzo: l’imperatore Giovanni VIII Paleologo e suo fratello Demetrio; il patriarca di Costantinopoli, Giuseppe II; con Gregorio, confessore dell’imperatore, 20 metropoliti (cinque dei quali fungevano anche da procuratori dei patriarcati di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme); diaconi, monaci e cortigiani. In tutto erano circa 700 persone. Secondo gli accordi, tutte le loro spese per il viaggio, il ritorno e il mantenimento in Italia dovevano essere pagate dal Papa. Alla solenne inaugurazione del 9 aprile, oltre ai greci, erano presenti 118 prelati latini. Giovanni VIII, tuttavia, aveva chiesto un rinvio di quattro mesi prima di qualsiasi discussione dottrinale, per dare agli stati dell’Europa occidentale il tempo di inviare dei propri rappresentanti, dal momento che desiderava un aiuto militare per Costantinopoli, minacciata dai turchi. Per soddisfare l’impazienza latina, a giugno si incominciò a discutere della dottrina del purgatorio tra due commissioni di dieci persone. I latini proposero una purificazione delle anime mediante il fuoco; i greci, accettando la possibilità di un sollievo per i defunti, negarono il fuoco e affermarono che le anime attendono il Giudizio Universale prima di accedere al loro stato finale. Non era stato raggiunto alcun accordo quando la peste si abbatté su Ferrara. In questo periodo (agosto 1438) arrivò Isidoro, metropolita di Kiev e di tutte le Russie.
Il concilio vero e proprio iniziò l’8 ottobre. Il cardinale Bessarione di Nicea (uno dei sei portavoce dei greci) tenne un discorso di apertura e poi Marco Eugenico, metropolita di Efeso, introdusse l’argomento scelto dai greci: la legittimità dell’aggiunta da parte dei latini delle formula del Filioque (in forza della quale si afferma che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio) al Credo niceno. In 13 sessioni, dall’8 ottobre al 13 dicembre, i greci sostennero che qualsiasi aggiunta al Credo, anche di una sola parola o sillaba, anche se facente riferimento ad una dottrina verace, era stata proibita dal Concilio di Efeso (431). Bessarione parlò in due sessioni e Marco Eugenico in tutte le altre. I latini interpretavano il divieto stabilito ad Efeso come riferito alla fede espressa dal credo, non alla formula esatta con cui questa era espressa. Dei sei oratori latini nominati, il cardinale Cesarini fu quello più attivo. Anche qui, non fu raggiunto alcun accordo. I greci, stanchi e scoraggiati, volevano abbandonare i concilio e fare vela per le loro terre. Eugenio, in ristrettezze economiche e minacciato dalle truppe del Ducato di Milano. Convinse la delegazione greca a recarsi a Firenze (10 gennaio 1439) per continuarvi la discussione sulla dottrina del Filioque.
Firenze
Dopo una riunione preliminare di due commissioni di 40 persone il 26 febbraio, si tennero otto sessioni tra il 2 e il 24 marzo. I latini sostenevano che all’interno della Santissima Trinità lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio (ex Patre Filioque), mentre i greci sostenevano la processione dal solo Padre. Giovanni di Montenero fu l’unico oratore per i latini; Marco Eugenico per i greci. Cinque sessioni furono dedicate in gran parte alla discussione su quale parte avesse i testi più accurati di alcuni passi dei Padri, soprattutto dell’Adversus Eunomium di Basilio. Nella sesta, Marco citò le Scritture, i concili e i Padri a sostegno della posizione greca. Nella settima e nell’ottava, il Montenero utilizzò le stesse fonti a favore della dottrina latina. Il risultato fu una situazione di stallo.
Nei due mesi successivi, in un’atmosfera di frustrazione e pessimismo, i latini sollecitarono altre sessioni; i greci, stanchi di discutere, chiesero che fosse indicata una strada diversa per sancire l’unione, altrimenti avrebbero abbandonato definitivamente il concilio (11 aprile). Le riunioni delle commissioni non portarono alcun frutto. I latini presentarono un’accurata dichiarazione di dottrina (cedula); i greci la emendarono con ambiguità. Furono sollecitati a chiarire meglio il loro pensiero, ma ancora una volta, constatato come la discussione fino a lì portata avanti fosse stata piuttosto inconcludente, minacciarono di andarsene (21 maggio). Come ultima risorsa, Eugenio si rivolse al concilio il 27 maggio, congratulandosi, incoraggiando, rimproverando ed esortando. Le sue parole diedero un nuovo impulso agli sforzi per l’unione.
I prelati greci ritenevano che ogni santo, proprio in quanto santo, fosse ispirato dallo Spirito Santo e quindi non potesse sbagliare nella fede. Anche se a volte le formule dai santi erano a volte diverse, il significato delle stesse doveva necessariamente essere univoco. Questo cosa fu sostenuta con vigore da quei greci che desideravano più ardentemente che si sancisse l’unione. I santi latini affermavano che lo Spirito Santo “procede dal Padre e dal Figlio”; i santi greci scrivevano variamente “esce da”, “emana da”, “scaturisce da”, “dal Padre”, “dal Padre e dal Figlio”, “da entrambi”, “dal Padre attraverso il Figlio”. Il patriarca Tarasio aveva detto: “procede dal Padre attraverso il Figlio”. Una volta che i greci accettarono che i Padri latini avevano davvero affermato il Filioque (la maggior parte di loro non conosceva il latino e quindi non conosceva direttamente gli scritti dei Padri latini), la questione fu risolta (29 maggio). Era necessario affermare, quindi, che nonostante le diverse formulazioni la fede era la stessa, pertanto l’unione non era solo possibile, ma necessaria (3 giugno). L’8 giugno la cedula latina sulla processione fu accettata dal sinodo greco. Il 10 giugno Giuseppe II morì e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Novella.
Nelle sei settimane successive i latini consegnarono ai greci le cedulae sul primato papale e sull’eucaristia (che furono spiegate in due sessioni, il 16 e il 18 giugno), e sul purgatorio. Ci furono difficoltà, tensioni e concessioni da entrambe le parti prima di raggiungere un accordo. Ulteriori attriti sorsero per la formulazione del decreto, composto dalle cedulae precedentemente concordate, alle quali furono aggiunte un’introduzione e una conclusione. La Laetentur caeli che ne risultò fu promulgata in seduta solenne il 6 luglio 1439, firmata da Eugenio e 116 latini e dall’imperatore con 32 greci, quattro dei quali agirono come procuratori di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Entrambi i gruppi concordano sul fatto che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da un unico principio. Per l’eucaristia si stabilì che il pane lievitato e quello non lievitato sono entrambi legittimi. Si decretò altresì che, dopo la morte, alcune anime devono essere purificate mediante delle specifiche pene, mentre altre vengono condannate all’inferno o assurgono, con diversi gradi di beatitudine, in paradiso. Il Papa è il successore di San Pietro, capo e maestro di tutta la Chiesa, e successore della pienezza di potere data da Cristo a San Pietro.
Mentre i greci partivano, due rappresentanti degli armeni arrivarono da Caffa (13 agosto). Nella bolla Moyses vir (4 settembre), Eugenio contesta l’ecumenicità del Concilio di Costanza che aveva decretato il primato conciliare e condanna Basilea per aver osato “deporlo”. L’unione con gli armeni fu promulgata il 22 novembre 1439, nell’Exultate Deo (il Decreto per gli armeni). Il 4 febbraio 1440, con la Cantate Domino, fu stabilita l’unione con la Chiesa copta d’Egitto e, dopo che il concilio si fu spostato in Laterano a Roma (24 settembre 1443), furono concluse unioni con alcuni siriaci (30 aprile 1444) e con caldei e maroniti di Cipro (7 agosto 1445). La data di conclusione del concilio non è certa, poiché non esiste alcun documento di chiusura. Nel frattempo, per adempiere all’obbligo assunto a Firenze, Eugenio aveva indetto una crociata per cacciare i turchi dall’Europa. Vi parteciparono solo la Polonia e l’Ungheria via terra e la Borgogna e Venezia con le navi papali via mare. A Varna (10 novembre 1444) l’esercito cristiano fu sconfitto e il cardinal Cesarini e il re Ladislao di Polonia-Ungheria furono uccisi. Un potente argomento a favore dell’unione, quello di un aiuto militare in qualche modo determinante a favore di Costantinopoli, perse così tutta la sua forza.
Conclusioni
L’unione con i Greci non durò a lungo. Marco Eugenico, da sempre oppostosi all’unione nei termini imposti dai latini, trovò un pronto sostegno nei monaci, nei vescovi e nella popolazione di Costantinopoli. A favore dell’unione furono Bessarione, Isidoro, Doroteo di Mitilene, Metrofane (successore di Giuseppe II) con almeno altri cinque (dei 18 firmatari episcopali greci), e il patriarca Gregorio III, successore di Metrofane.
La ragione comunemente addotta nel mondo ortodosso per giustificare la mancata ricezione delle decisioni del Concilio di Firenze consiste nel fatto che l’unione non non fu mai autentica e che i delegati orientali avevano aderito alle decisioni conciliari sotto costrizione. Ora, che alcuni dei greci soffrissero per l’incapacità del papa e che la loro prolungata permanenza in Italia e lo scarso successo nel convincere i latini a discutere li avesse angosciati e depressi è evidente. Più discutibile è di certo l’idea secondo cui i delegati orientali avessero sottoscritto i pronunciamenti conciliari esclusivamente in ragione della pressione psicologica esercitata su di loro dalla minaccia militare turca e la speranza di ricevere aiuto dall’Occidente. Dopo il fallimento delle sessioni di Ferrara, infatti, i greci erano pronti a tornarsene in patria. Inoltre, dopo le sessioni di Firenze diedero per due volte un ultimatum al papa. In nessuno dei due casi, tuttavia, vi fu il minimo segno che essi si fossero lasciati intimorire dal bisogno o opprimere dalla situazione della loro patria; al contrario, essi resistettero risolutamente alle pressioni latine. Si è anche sostenuto che l’imperatore, deciso a sancire l’unione per il bisogno disperato di un sostegno occidentale per non perdere quel poco che ormai restava del suo dominio, non permise ai delegati greci alcuna vera libertà di parola. Da quanto possiamo ricostruire dalle fonti a nostra disposizione, però, nelle sessioni i greci ebbero modo di parlare con la stessa frequenza dei latini e in quasi tutte le sessioni, l’unica voce tenacemente contraria all’unione fu quella di Marco Eugenico. Inoltre, Marco (come lui stesso testimoniò in seguito) parlò sempre liberamente nelle riunioni private greche, non firmò il decreto e fu riportato a Costantinopoli con la nave imperiale. Si deve quindi concludere che i greci in Italia, pur subendo certamente alcune limitazioni ed essendo altrettanto certamente sottoposti ad una notevole pressione psicologica, mantennero comunque un’ampia libertà di azione e di espressione. Possiamo sostenere che a Firenze tutti coloro che sottoscrissero le decisioni del concilio lo fecero liberamente, anche se in alcuni casi influenzati più dall’esempio che dalla convinzione, anche se poi, tornati in patria, alcuni di costoro abiurarono. Di conseguenza, nella stessa Costantinopoli ci fu una forte divisione. L’imperatore, pur essendo lui stesso fedele all’unione, fece poco per imporla. L’unione fu promulgata ufficialmente solo il 12 dicembre 1452 da Isidoro di Kiev, in qualità di legato papale, all’ombra dell’attacco turco. Maometto conquistò Costantinopoli il 29 maggio 1453 e l’unione terminò lì.
Adriano Virgili
Alcuni riferimenti bibliografici:
Pietro Palazzini (a cura di), Dizionario dei concili, Roma, Città Nuova, 1963-1968, VI Voll.
Giuseppe Alberigo (a cura di), Decisioni dei concili ecumenici, Torino, UTET, 1978
Pierre-Thomas Camelot, Paul Christophe, Francis Frost, I concili ecumenici, Brescia, Queriniana, 2001
Klaus Schatz, Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali, Bologna, EDB, 2012
Marina Benedetti (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età medievale (secoli VIII-XV), Roma, Carocci, 2015
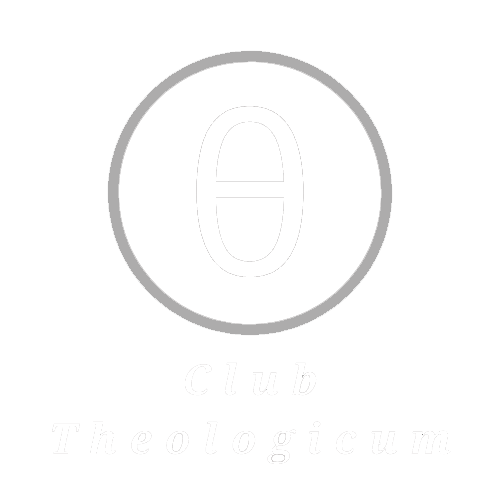

Lascia un commento